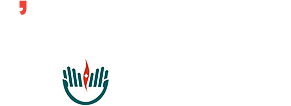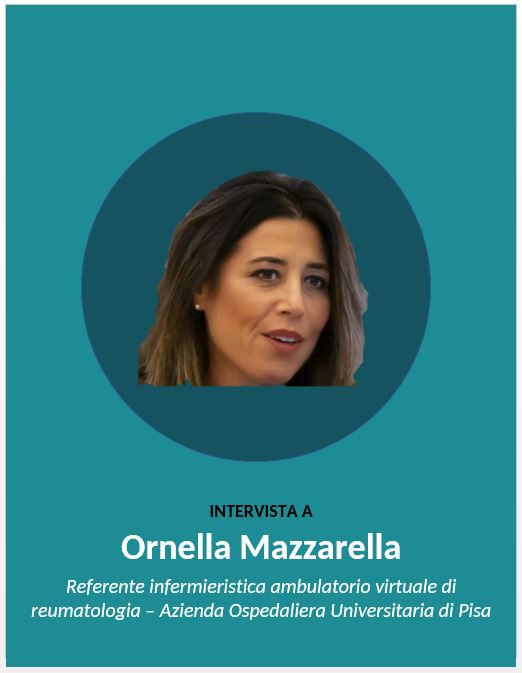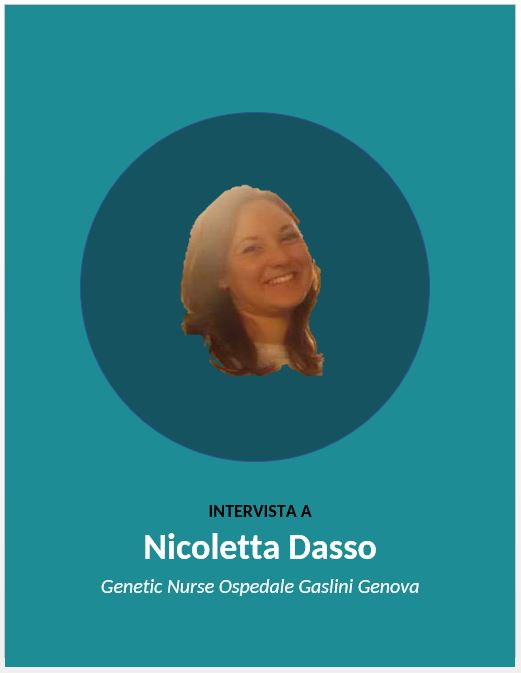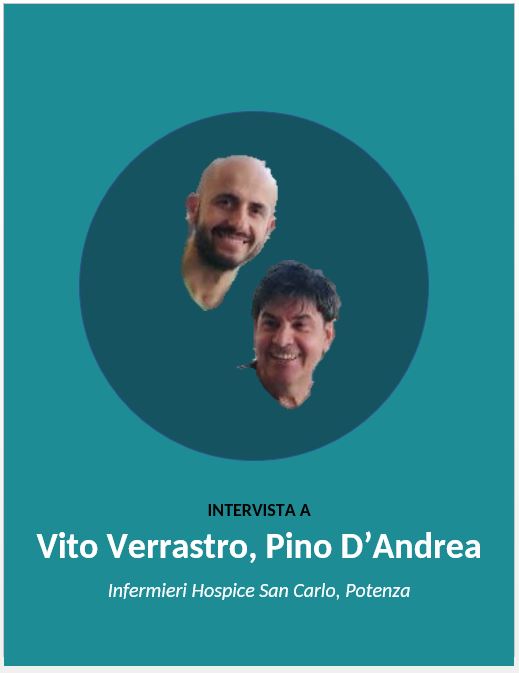Cura e bellezza vanno di pari passo? Si può parlare di bellezza nella cura? La bellezza nella cura è soggettiva o oggettiva? Cura davvero? Come? Quale bellezza? Come si concretizza nella cura?
Sono solo alcuni degli interrogativi quasi inevitabili quando si pone l’attenzione su questo binomio, bellezza e cura, e sull’influenza dell’una sull’altra.
Per provare a “guardare dentro” la bellezza che cura abbiamo chiesto a Paola Arcadi Direttore didattico del Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano, ASST Melegnano e Martesana di accompagnarci.
Parlare di bellezza è impossibile.
Non è un’idea, la bellezza: è un’esperienza.
Facciamo esperienza del bello in ogni incontro con qualcosa o qualcuno nel cammino della nostra vita. Così come ci accade con la cura. La vita è infatti una continua esperienza di cura ricevuta, fin dalla nascita, nelle esperienze di relazione con le persone significative che si incontrano nel cammino della vita stessa. Il “come” veniamo curati, molto spesso influenza il modello di cura che portiamo all’altro.
Una cura che può contenere la bellezza. Dove? Nella qualità dell’incontro. Nel tu ed io, nel noi.
La bellezza, dice Kahlil Gibran “è un’immagine che vedete con gli occhi chiusi, un canto che udite con le orecchie chiuse”(1). In altre parole, la bellezza non è un dato empirico, non può essere misurata, pesata, contata, studiata per prove ed errori. La bellezza, insomma, non è un oggetto, una “cosa”, ma una connessione, una relazione.
Una relazione curante autentica ha in sé gli attributi della bellezza.
Ne scorriamo insieme qualcuno.
L’IN-UTILITÀ
Kant – nella sua critica del giudizio estetico – afferma che “è bello ciò che piace senza concetto e senza scopo”(2); la bellezza, ossia, si iscrive nella dimensione dell’inutile, ed è proprio per questo motivo che assume senso, in un mondo in cui invece molto si fonda sull’utile e sull’utilitaristico.
L’esperienza della bellezza è in primis un’esperienza di purezza, o per dirla con Kant, un’esperienza disinteressata. La bellezza provoca piacere, stupore, non ha un utilità, e scaturisce da una relazione con il soggetto che riflette su se stesso e che conclude con un giudizio sulla bellezza.
La cura autentica, la cura intrisa di bellezza, è anch’essa oltre l’utile; assumere la cura come utile rischia infatti di iscriverla nell’alveo del profitto: “ti curo perché mi torna indietro qualcosa”, oppure “ti curo perché mi occupo di te e perché a te serve qualcosa”. Possiamo curare in modo inautentico e utilitaristico oppure in modo autentico. L’uomo può infatti occuparsi delle cose che si devono procurare per l’altrui utilizzo, oppure offrire agli altri la possibilità di trovare se stessi, di prendersi cura di sé per realizzare il proprio essere (3). Il primo caso non permette la co-esistenza, quell’essere-con, quella possibilità di guardare alla totalità dell’altro partendo dalla comprensione del suo mondo e del suo particolare modo di concepire la sua salute e la sua malattia, e conduce inevitabilmente ad una riduzione della potenza curatrice, poiché lo sguardo è rivolto alla prestazione, talvolta anche all’esito, ma all’esito oggettualizzato, al “so io cosa è giusto per te”. Mentre nel secondo caso è un vero co-esistere, capace di formare un mondo comune. L’inautenticità può emergere – come paradosso – persino quando si esercita una professione di cura allorché ci si occupa degli altri come oggetti, come portatori di malattie e disabilità, e non come persone con cui formare un mondo comune (4).
L’IMPERFEZIONE e il LIMITE
Mentre il pane si cuoce alcune sue parti si screpolano e queste venature che vengono così a prodursi, e che in un certo senso contrastano con il risultato che si prefigge la panificazione, hanno una loro eleganza e un modo particolare di stimolare l’appetito. Ancora: i fichi pienamente maturi si presentano aperti. E nelle olive che dopo la maturazione sono ancora sulla pianta è proprio quell’ essere vicine a marcire che aggiunge al frutto una particolare bellezza.
(Pensieri, Marco Aurelio)
La vera forma della bellezza è non rinunciare alle screpolature del pane, e la bellezza che cura è dare valore alle nostre imperfezioni.
Viviamo in un mondo che esalta la perfezione, anche nella dimensione della medicina e della cura: il corpo bello è il corpo perfetto, la performance sempre al massimo è lo stile di vita che si guarda come riferimento. Cosa vi è invece di più imperfetto di una malattia? Quella che segna il corpo così come quella che segna l’anima. Curare l’imperfezione significa restituirle dignità e bellezza, così come ci consegna Rodin, nelle sue opere, nei suoi personaggi deformati, nelle sue parole: “Ciò che in natura viene considerato brutto spesso presenta maggior carattere di ciò che è qualificato bello, perché nelle contrazioni di una fisionomia malata, nei solchi di una maschera viziosa, in ogni deformazione, in ogni macchia d’infamia, la verità interiore riluce con più evidenza che non su lineamenti regolari e sani. È soltanto la Potenza del carattere che fa la bellezza dell’arte, accade spesso che quanto più un essere è brutto in Natura, tanto più è bello in Arte. Sì, anche nella sofferenza, anche nella morte delle creature amate e persino nel tradimento di un amico, il grande artista trova la tragica voluttà dello stupore”(5).
La relazione di cura accogliente, che vive quell’accettazione positiva incondizionata Rogersiana, è quanto di più nobile possiamo mettere in gioco nell’incontro, ed ha una potenza curativa davvero grande. Accogliere l’altro, ri-partire dai suoi limiti, trasformarli in opportunità, è una delle grandi sfide della cura oggi, nel mondo in cui le cicatrici dei nostri limiti non guariscono, ma si accompagnano con benevolenza nel nostro cammino di vita, e anche oltre la vita, nell’incontro con la morte che travalica i limiti.
La parola stessa “incontro”, contiene “In” (speranza), e “contro” (limite) nello stesso etimo. “In” è andare verso, cercare l’unione. “Contro” è sperimentare resistenza, opposizione. L’incontro è insieme esperienza del limite e della speranza. Sono entrambi necessari per passare dall’essere individui oggettivati a persone capaci di incontrarsi e produrre un cambiamento. L’in-contro produce un cambiamento, una trasformazione.
L’altro vorrà incontrarsi con me? È una domanda poco consueta, la cui risposta non è scontata, in particolare nella relazione di cura. Curare significa accettare il rischio dell’incontro, dove il limite non si riduce. Significa rischiare la fatica che si genera quando qualcuno carica l’altro di aspettative, richieste, e che può sfociare nell’identificazione che annulla o nel distacco che allontana, che trova unico spazio di movimento nella standardizzazione eccessiva, nella procedura che protegge, nell’oggettivizzazione che non pone domande scomode.
Il senso vitale della cura, invece, è fare di “limite e speranza” condizioni generative.
LA LIBERTÀ
Solo attraverso l’esperienza del bello l’individuo può ritrovare la sua centralità, e quindi la sua libertà. La bellezza che cura si muove in un terreno di libertà, il cui obiettivo è la salute. Nel 3° rapporto GIMBE sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale si fa espresso riferimento alla libertà: “Il successo di un servizio sanitario non può essere misurato solo con classifiche e indicatori, ma deve essere valutato soprattutto sulla base delle libertà che il nostro stato di salute ci concede per scegliere la vita che desideriamo vivere”(6).
Così come il gusto, quindi, è una facoltà che ciascuno esercita da sé, così anche le decisioni in termini di salute devono poter essere esercitate in un contesto di autonomia, cioè di libertà.
Aiutare l’altro a decidere liberamente per la propria salute raffigura infatti uno tra i più elevati scopi di una relazione curante, ed è nel luogo della decisione e del supporto all’autodeterminazione che si sostanzia inoltre la nobile funzione di advocacy di chi cura (7), quell’essere garanti che si basa sul riconoscimento dei diritti umani e cogenti del paziente, affinché si porti questi ad una sua individuale e personale responsabilizzazione (8).
L’ARMONIA (RICOMPORRE LA COMPLESSITÀ)
Nella visione classica, la bellezza è armonia.
Armonia delle forme, simmetria e proporzione tra le varie parti di un oggetto, tra aspetti ed elementi diversi di una stessa realtà. Nella bellezza armonica, la molteplicità di questi elementi viene ricondotta ad unità, ad un ordine nel quale ciascuno svolge la propria funzione, e risponde ad un principio di organizzazione.
La bellezza dunque non è nei singoli elementi ma nell’insieme.
La bellezza che cura è quella che fa dell’incontro una possibilità di ricostituzione dell’armonia. Un’armonia perduta, da una parte, ma sempre più evidente dall’altra.
Armonia perduta perché quella visione di salute Ippocratica che considera l’uomo in una dimensione unitaria, (l’olos) e la cura come una ricostituzione dell’armonia, pare essere lontana dallo sguardo dominante. Il progresso tecnologico, il sostituirsi progressivo della conoscenza tecnica al sapere umanistico, l’iper specializzazione delle conoscenze scissa da un processo culturale di riconoscimento dell’irriducibilità della persona umana alle cose, stanno lentamente conducendo la società occidentale alla “perdita di ogni forma di meraviglia davanti all’esistente, per lasciar posto alla scomposizione dell’uomo e della natura, attraverso il moltiplicarsi delle diverse scienze particolari, che, se possono dare indicazioni preziose sull’uomo e ciò che lo circonda, rischiano di trasformare ciò che è uno in molteplice”(9).
Armonia evidente, invece, nel nostro tempo, costellato da situazioni di malattia non scomponibili, bensì strettamente interconnesse, e che ci riconducono alla visione sistemica e alla complessità. La relazione di cura guarda e si meraviglia davanti all’umana complessità, e si muove per mantenere o ricomporre quell’unità. Tenere insieme e riformulare costantemente il senso, per rendere le persone il più possibile capaci di reggere e mantenere la complessità, è tra le più nobili funzioni dell’incontro di cura.
TRAFITTI DALLA BELLEZZA DEL NOI IN RELAZIONE
“La bellezza ci può trafiggere come un dolore”
(Thomas Mann).
La bellezza colpisce, trafigge, non lascia indifferenti. L’esperienza dell’incontro nella cura è qualcosa che ferisce, che penetra e che talvolta ci lascia impotenti: di fronte al dolore, alla sofferenza, alle storie di malattia, rimaniamo colpiti e inermi, per un tempo più o meno lungo nel quale i sentimenti, le emozioni che ci arrivano si incontrano con i nostri sentimenti, le nostre emozioni e le nostre ferite. Che richiedono anzitutto di essere conosciute e accolte.
Assumere il noi come elemento costitutivo della relazione curante, che parte da un IO E TE, significa riconoscere che siamo rami dello stesso albero, e che l’ascolto dell’altro è possibile solo attraverso l’ascolto di noi stessi.
L’essere curante è una scelta che è – al contempo – dono e fardello, in una dimensione di alterità che sollecita incessantemente emozioni talvolta contrapposte, ma che sempre necessitano di essere toccate e rielaborate.
Il ‘mestiere’ della cura è molto oneroso, in quanto richiede di decentrarsi per dare spazio alle richieste di aiuto di un’altra persona.
Presenza autentica significa però portare all’altro un noi altrettanto autentico, fatto di pienezza, mai di vuoto. Non possiamo avere interesse per qualcuno se esauriamo o ci viene richiesto di esaurire l’interesse per noi stessi. In sintesi: non possiamo aver cura autenticamente di qualcuno se non coltiviamo la cura per noi stessi.
Solo chi è “sano” può infatti offrire il giusto e adeguato aiuto.
Il professionista sano è quello che ha fatto i conti con i propri limiti, le proprie ferite, le proprie malattie, con tutto ciò che ha trafitto, ricordando la metafora del guaritore ferito, il mito di Chirone. Accanto all’aspetto demiurgico del sapere e dell’arte, emerge infatti il dolore contenuto nella comune matrice umana, corporea e mortale, che unisce, al di là dei ruoli, curante e paziente (10). La repressione di uno dei due poli della coppia porterebbe il curante a una soglia pericolosa caratterizzata dalla convinzione di non avere nulla a che fare con la malattia. Un curante senza ferita non può attivare il fattore di guarigione nel paziente e la situazione che si crea è tristemente nota: da un lato sta il curante, sano e forte, dall’altro il paziente, malato e debole. La comprensione di ‘ciò che passa dentro’ quando ci relazioniamo con gli altri, l’accettazione di ogni sentimento, anche quelli più negativi, raffigurano dunque il principio di ogni relazione, poiché se non riconosciamo le nostre fragilità, se non accettiamo e includiamo ogni sentimento che l’altro ci evoca, il grande rischio è di rimuoverli, di non farne esperienza. E in ogni caso, nella professione così come nella vita, quando non affrontiamo ciò che siamo, prima o poi ci viene chiesto conto. E come si manifesta il non lavoro su noi stessi in ambito di relazione con il paziente? Con il rifiuto celato nell’indifferenza, con il distacco, con l’incapacità a reggere la relazione. Ecco che invece riconoscere le nostre fragilità è modo per affrontarle, talvolta restituirle al paziente, ma con autenticità e congruenza.
Essere autentici è il primo e grande impegno per poter aiutare l’altro.
La bellezza non ha tempo, è oltre il tempo. Così anche la reazione curante. Un tempo opportuno, nel quale si dispiega la cura, autentica e semplice, come accade nella Grande Bellezza, il film di Sorrentino, in cui il protagonista cerca la bellezza, e la ritrova lontano dalla bellezza esteriore delle sontuose feste romane, nell’autenticità e nella semplicità.
“E ora che fate?” “Dopo che ha stirato, ci beviamo un bicchiere di vino, vediamo un film e poi andiamo al letto insieme.” “Che belle persone che siete!” “Appunto! Chi di noi ha la fortuna di vivere felice la semplicità?”
La bellezza che cura è nelle piccole cose, nei piccoli gesti di cura quotidiani, carichi di significato sia per chi li dona sia per chi li riceve.
Marina Vanzetta
7 giugno 2023