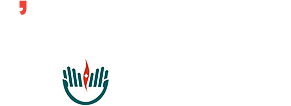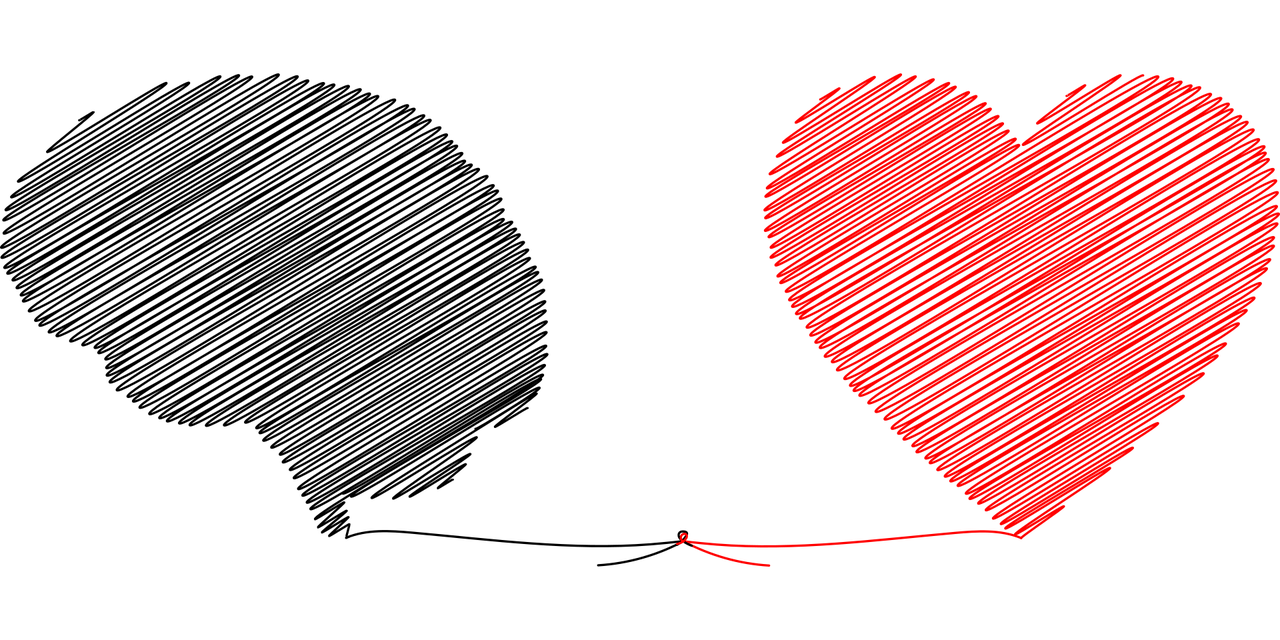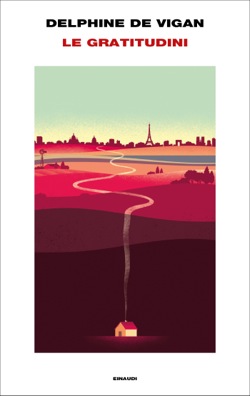
Delphine de Vigan
Einaudi Editore 2020
Pagine 160
Ci sono personaggi letterari con i quali possiamo sviluppare una sintonia profondissima: ci diventano più intimi dei nostri stessi parenti. La romanziera francese Delphine de Vigan ci espone a questo rischio con Michèle Seld, che gli amici chiamano Michka. È la protagonista di Le gratitudini (Einaudi, 2020). È anziana, molto. Ha dovuto apprendere su sé stessa che “invecchiare è imparare a perdere”, come teorizza Jérome, l’ortofonista che ha sviluppato con lei una relazione non solo professionale, ma di grande intesa umana. La incontriamo in una residenza per anziani, dopo che vivere in autonomia a casa sua è diventato progressivamente impossibile. Anche Marie, la sola presenza nel cerchio delle sue amicizie – profondamente grata perché quando era bambina Michka ha sostituito sua madre, non all’altezza di questo compito – ha dovuto arrendersi.
La RSA che l’accoglie non produce nessuno dei maltrattamenti che, sulla base di sporadiche cronache giornalistiche, costituiscono un incubo per molti di noi. Tanto realistico che Stephen King, che di brivido se ne intende, ha potuto costruire un romanzo, Il miglio verde, sulla paura di venirsi a trovare, in una struttura di questo genere, come vittima privilegiata di un infermiere con tendenze sadiche. Non è questo lo scenario che accoglie Michka. Piuttosto il contrario. Appena ricoverata, entra nella stanza una donna che le offre uno spuntino: “Un succhino di mela con la sua cannuccina e con un biscottino confezionato in un pacchettino. Ecco che cosa ti aspetta, Michka: passettini, sonnellini, merendine, uscitine, visitine. Un’esistenza sminuita, ristretta, ma perfettamente regolata”. E l’infermiera che le parla a voce altissima, come a una bambina.
Siamo al polo opposto della prevaricazione violenta, ma ugualmente lontani dai comportamenti auspicabili. Tom Kitwood, esperto di psicosociologia gerontologica, ha denunciato comportamenti di cura che, malgrado l’intenzione, sviluppano modalità subdole che sviliscono o non tengono nel giusto conto gli interlocutori delle nostre interazioni quotidiane. Nei contesti di cura per persone molto anziane o non più autosufficienti tali pratiche passano per lo più inosservate o vengono semplicemente considerate normali. Coloro che si sono sensibilizzati al problema lo hanno identificato con l’etichetta “psicologia sociale maligna” (cfr. Giorgio Bissolo: Relazioni di cura. Introduzione alla Psicologia sociale maligna, Carocci, 2009). Si va dall’infantilizzazione alla disconferma, passando per numerosi altri comportamenti invalidanti sotto la copertura della benevolenza. “Sono buono, quindi ti danneggio”, si potrebbe sintetizzare. Il tutto riassumibile nel termine disempowerment, cioè l’opposto di quell’empowerment che è l’obiettivo ideale di un rapporto di cura in epoca di modernità.
Ma non è questo il centro dei problemi di Michka. È sufficientemente equipaggiata per farsi rispettare e non sprofondare nella perdita di identità e del rispetto di sé. Quello che sta perdendo invece è il linguaggio: le parole si sbriciolano, si confondono o semplicemente non si presentano alla mente. “Senza il linguaggio, cosa resta?”, si chiede l’ortofonista che affronta con lei il compito, perduto in partenza, di arrestare la slavina. Per Michka, che ha passato la vita lavorando in un’importante rivista, le parole sono la sua ricchezza. Anche con l’aiuto del generoso ortofonista, non riesce a recuperare il linguaggio, che scende inesorabilmente come sabbia in una clessidra. Come molte persone sulla soglia estrema, Michka ha quello che in psicoterapia si chiamerebbe un unfinished business: qualcosa che vorrebbe portare a termine. Lo psichiatra canadese Harvey Chochinov ha costruito su questo bisogno un intervento specifico, che ha chiamato “terapia della dignità” (Harvey Chochinov: Terapia della dignità. Parole per il tempo che rimane, Il Pensiero Scientifico 2015).
Il compito non portato a termine da Michka è un gesto di ringraziamento verso la famiglia che l’ha ospitata da bambina. Durante l’occupazione nazista della Francia, lei ebrea rischiava di essere deportata. La madre l’ha affidata a una coppia che ha casualmente incontrato, prima di finire lei stessa in un campo di sterminio. La coppia ha nascosto la bambina per tre anni, a proprio rischio. Ora Mishka, prima di concludere la sua vita, vorrebbe far giungere il suo ringraziamento ai suoi salvatori. Sulla base della sua esperienza acquisita sul campo, osserva l’ortofonista Jérome: “Crediamo sempre di avere il tempo di dire le cose, e poi all’improvviso è troppo tardi. Due o tre cosette di commiato…’È stato bello’, ‘Felice di averla conosciuta’, ‘Onoratissimo’, ‘Piacere’, ‘Buon viaggio’, ‘Buona continuazione nell’ignoto’, ‘Grazie di tutto’, non so!”. Per Michka la parola da dire è una sola: “Grazie”. E riesce, con l’aiuto di chi l’assiste benevolmente, a farla arrivare alla donna che l’ha accolta e protetta, ormai centenaria e ospitata a sua volta in una residenza per anziani. Sì, proprio quella parolina che diciamo con leggerezza decine di volte al giorno, accompagnando gli scambi e le interazioni più banali. Ma il “Grazie” di Michka, intorno al quale è costruito il racconto de Le gratitudini, non è una semplice formula di cortesia. Ha una valenza tutta speciale: è la spina dorsale che tiene in piedi la narrazione di una vita intera.
La romanziera è così discreta che lascia solo supporre, da qualche indizio, che l’ultimo passo di Michka sia stato un distacco volontario dalla vita, dopo che la fonte delle parole si era prosciugata e l’ultima parola era stata detta. Un dettaglio insignificante, in fondo: attraverso la gratitudine, la sua esistenza aveva preso forma completa a quell’esistenza. Un’autorealizzazione spirituale. È l’auspicio più alto che osiamo formulare per noi stessi e per tutti coloro che aspirano a una vita in pienezza.
RIVISTA BIMESTRALE
Organo ufficiale della Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche