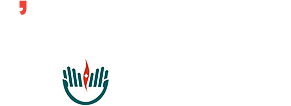Parliamo di fotografie. Delle foto in quanto possono contribuire alla crescita nella salute, collocandole quindi nel perimetro delle Medical Humanities. Prendiamo quindi le distanze da quell’uso delle foto nell’ambito di percorsi nella patologia che si va diffondendo nei social. Fino a non molto tempo fa, la reazione istintiva, quando di annunciava una malattia, era quella del nascondimento e della dissimulazione: far finta di niente. Ai nostri giorni prevale la tendenza opposta: ci si fotografa e si posta nel sito. Se ne fa oggetto di conversazione sociale, sotto forma di like. “Parlerò della mia malattia perché potrà servire anche a me”, annunciava di recente con candore un influencer, rendendo pubblica la sua vicenda terapeutica. Istruttiva l’inversione di prospettiva: dava per scontato che fosse di utilità ai follower, e magari anche al portatore stesso della malattia… “Selfie con malattia”, si potrebbe chiamare questo ricorso a una narrazione in funzione dell’ego (e del consumo: siamo sorpresi nell’apprendere quanti soldi girano con i clic a queste immagini!). In questo contesto la fotografia più che una risorsa terapeutica siamo tentati di considerarla un nutrimento della patologia narcisistica.
“Paulo majora canamus”, con le parole del poeta che invitava a elevare il livello del canto. Le fotografie alle quali vogliamo dedicare la nostra attenzione sono quelle alle quali attribuiamo diritto di cittadinanza nelle Medical Humanities. In questo ampio arsenale di risorse ci sono le parole, anzitutto. Quelle della poesia, della narrazione letteraria, delle scienze umane. E ci sono le immagini: da quelle visive create dall’arte a quelle uditive, suscitate dalla musica. Per quanto riguarda l’arte, è sufficiente rimandare alle tecniche denominate Visual Thinking Strategies (1). Questa metodologia è finalizzata a promuovere, mediante l’osservazione di opere d’arte e il confronto in gruppo sulle proprie percezioni visive, le competenze chiave per la cura. Soprattutto negli Stati Uniti è un approccio utilizzato per un apprendimento innovativo rivolto a studenti di medicina, medici, infermieri e altri professionisti.
Sempre nell’ambito delle Medical Humanites, un’attenzione merita anche la fotografia. Superfluo ricordare quanto le foto abbiano svolto un ruolo di denuncia e di sensibilizzazione sociale: per esempio quanto la chiusura dei manicomi in Italia sia debitrice alle foto che hanno reso pubbliche le condizioni di degrado in cui versavano i malati mentali in quelle istituzioni; o quanto certe foto shockanti abbiano canalizzato l’attenzione sui malati di Aids, una realtà che si tendeva a nascondere. In una prospettiva più ampia, la fotografia ha fatto luce sulla condizione di malattia e sul percorso verso la morte. “Alcuni fotografi, nel momento in cui la malattia, la morte e il dolore li hanno colpiti negli affetti personali o nella loro persona, hanno trovato nella fotografia lo strumento catartico che poteva fermare il processo di annichilamento, congelando quei corpi e quei volti destinati a scomparire”: lo afferma e lo documenta Davide Colombo in un capitolo sulla malattia e sulla morte in fotografia nel manuale curato da Oscar Corli e Roberta Vecchi: Siamo anime e corpi, dedicato all’apporto delle Medical Humanities per delineare “altri orizzonti per le cure palliative” (2).
Un’applicazione singolare delle foto nel progetto di cura è quella che le utilizza per attivare ricordi in persone affette da decadenza cognitiva, in particolare malati di Alzheimer e ospiti di residenze sanitarie. Ne riferiscono Ayres Marques (3) e Tiziana Tesauro (4). In particolare il “Progetto Memory”, di cui riferisce dettagliatamente il secondo dei due saggi ai quali ci riferiamo, è centrato sulla narrazione come pratica di attivazione dei residenti passivizzati dal ritmo quotidiano di una RSA. Non manca tuttavia di problematizzare strategie di questo tipo. È necessario chiedersi: far entrare la narrazione in queste strutture è solo tenera nostalgia o può riversarsi nel suo contrario, ovvero in un gioco crudele?
Senza ambiguità si presenta invece una proposta nutrita di fotografia. Ce la propone il dottor Momcilo Jankovich, che molti lettori conoscono con il nome gentile di Dottor Sorriso: un tratto che porta inciso nel suo stesso nome, dal momento che in serbo Momce-cilo significa “ragazzo gaio” (5). Ma soprattutto hanno confidenza con lui migliaia di giovani malati e i loro famigliari: li ha curati per patologie oncologiche, in più di 40 anni di attività clinica. E, benché in pensione, è tuttora in prima linea. Questa volta il farmaco a cui ricorre non né la chemio, né la radio: è esplicitamente la fotografia. Con la collaborazione della collega Monica Terenziani e soprattutto del fotografo Attilio Rossetti, ci offre un volume di grande formato: Famiglie inaspettate. Tornare alla luce dopo la malattia (6).
La premessa è un dato confortante: le terapie mediche hanno fatto negli ultimi anni progressi strepitosi. I tumori pediatrici, che una volta avevano come esito inesorabile la morte, ora vanno incontro alla guarigione nella media dell’80 per cento dei casi. Guarigione o “lunga sopravvivenza”? Non è una questione nominale: Jankovich è esplicito nel preferire la dizione più esplicita di guarigione. Tuttavia sa, da clinico, che nel futuro di questi bambini e giovani guariti ci possono essere recidive, nonché effetti negativi delle aggressive terapie ricevute. Alcuni ex malati preferiscono lasciarsi le tribolazioni alle spalle e immaginare che la parentesi sia definitivamente chiusa; per altri il pensiero inquietante cova sotto l’apparente normalità della vita. “Il percorso di cura di un bambino malato è buio: come va illuminato una volta raggiunta la guarigione?”, si domanda Jankovich. La sua risposta giunge sorprendente: la luce viene dalla nascita dei figli. Ecco dunque che, accompagnato dal fotografo, si introduce con discrezione nell’abitazione di ex malati e li fotografa. In famiglia, con i figli. Sono queste le “famiglie inaspettate”; eppure reali. Con i loro bambini, con i collage che riportano i momenti più sereni della loro vita, senza trascurare talvolta le reliquie del percorso lasciato alle spalle.
Il libro si iscrive a pieno diritto nell’ideale di cura promosso dalle Medical Humanities. Dove guarire è più che sconfiggere una patologia; dove prendersi cura di chi percorre lo spinoso cammino richiede anche di entrare, in punta di piedi, nei ripostigli meno illuminati, dove permangono inquietudini e paure, per farvi entrare un raggio di luce; dove il farmaco di eccellenza, come dimostra l’esperto di neuroscienze Fabrizio Benedetti, è la speranza, che attiva gli stessi percorsi neurologici che seguono i farmaci (7). La speranza si concretizza nella foto di un interno domestico, dove una famiglia – inaspettatamente – si è formata e sorride alla vita. Perché il dottor Jankovich non ha terminato il suo lavoro terapeutico finché non contagia gli altri con il suo stesso sorriso.
RIVISTA BIMESTRALE
Organo ufficiale della Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche