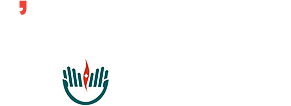PESCARE A CASO UN LIBRO QUALSIASI DI GEORGES SIMENON
Potete chiudere gli occhi e pescare, a caso, un libro qualsiasi tra le centinaia scritti da Georges Simenon: non rimarrete delusi. Ma potete fare di meglio e andarne a cercare uno speciale; non un’indagine poliziesca affidata al commissario Maigret, ma un romanzo-romanzo, nel quale Simenon ha riversato la sua profonda conoscenza dell’animo umano.
Suggerisco Le campane di Bicêtre, l’originale apparso nel 1963, la traduzione italiana (Adelphi) nel 2009. E lo propongo a coloro che esercitano professioni sanitarie, in particolare a infermieri/e. Non perché ne sia protagonista un componente della professione. L’infermiera, Blanche, ha piuttosto un ruolo secondario. Dedica le sue cure premurose a René Maugras, prestigioso direttore di un grande giornale, durante la sua degenza nell’ospedale di Bicêtre. Il malato, oltre ad ascoltare i rintocchi delle campane, può fare ben poco. È stato colpito da un ictus, è emiplegico e afasico. Nel silenzio in cui è murato ripercorre la propria vita, riflette sulle persone che fanno parte del suo mondo… e si interroga su Blanche. Se fosse in grado di parlare, le vorrebbe chiedere perché, giovane donna dotata di fascino e calore umano, ha deciso di passare la sua vita accanto ai malati.
Forse in questo caso l’afasia non è inopportuna: domande come queste entrano in un territorio troppo individuale, dove è necessaria la discrezione. Non siamo infatti nell’ambito di una generica riflessione sociologica, che ci porti a considerare i pro e i contro dell’abbracciare una professione sanitaria. Giusto per sintonizzarci su un saggio recente, pensiamo a Paolo Nucci: Perché (non) fare il medico, Piemme 2021. Quello che Maugras vorrebbe sapere da Blanche è qualcosa di strettamente personale. Domanda pienamente giustificata quando uno lo chiede a sé stesso: “Ma perché ho scelto di dedicarmi a curare malattie e fragilità altrui? Per quale motivo mi sono ritagliato la professione di ‘addetto al male’?”. Oltre alle circostanze contingenti, è probabile che la risposta rimandi a una originaria spinta ideale. Anche volendo evitare formule altisonanti come “vocazione” e “missione”, ci sentiamo avviati verso risposte di natura religiosa – come quel buon samaritano che decide di farsi prossimo per il disgraziato sul ciglio della strada, che altri non degnano di uno sguardo – o laica, ispirata alla filantropia. In ogni caso è attendibile che all’origine ci sia l’impulso di salvare, di assistere, di aiutare.
È quello spirito che tradizionalmente è stato simbolizzato dal giuramento ippocratico che troviamo nel codice genetico della medicina occidentale. Anche di recente i medici italiani, nel tentativo di riportare in equilibrio i rapporti con i malati sconvolti dalla pandemia, sono ricorsi a slogan di stampo antico: “Io medico giuro… di curare tutti senza discriminazioni; che avrò cura di te, in ogni emergenza”. È lo stesso spirito che anima chi la cura la pratica come infermiere. Chiunque curi è indotto a farlo dalla “com-passione”: con e senza trattino. La compassione è la spinta a rispondere operativamente cercando di porre rimedio al pathos che devasta il corpo degli esseri umani; la “passione” (separata dal trattino!) è invece il dinamismo interiore che induce a curare e a prendersi cura di chi è afflitto da qualche patologia.
PER SOTTRARCI ALLE INSIDIE DELLA RETORICA
Per sottrarci alle insidie della retorica, possiamo far nostra la risposta che uno studioso si sentì autorizzato a darsi in un saggio dedicato al giuramento ippocratico e alla sua evoluzione nei secoli. Fatta la tara all’enfasi e all’uso araldico che se ne fa in ambito medico, che cosa ne rimane, si chiedeva? “Si tratta di dare una risposta al ‘Chi me lo fa fare’, motto terribilmente sconfortante quando lo si sente usare cinicamente, appunto come una replica senza risposta” (Giacomo Mottura: Il giuramento di Ippocrate. I doveri del medico nella storia, Editori Riuniti 1986). La risposta c’è, a condizione che riaffiori almeno un residuo di “passione”. Può succedere che la spinta iniziale si sia trasformata. Non ci stupiamo: avviene nella vita di coppia più consolidata, dove l’innamoramento iniziale è sollecitato a cambiare forma, diventando amore. Ma se l’innamoramento diventa disamore, rimanere insieme può diventare autolesionistico. Nei rapporti di cura questa evenienza si chiama burn-out. Se la passione si spegne, la cura rischia di trasformarsi nel suo contrario: un’afflizione sia per chi la esercita che per chi la riceve. Se si vogliono prevenire danni immani, quando al burn-out non si riesce a porre rimedio è preferibile desistere dal dedicarsi alla cura.
Non è questa la situazione di Blanche nel romanzo di Simenon. Continua, con dedizione ed entusiasmo, a promuovere il benessere del suo paziente, portandogli ogni giorno un raggio di luce, oltre che cure appropriate. Una svolta nella relazione avviene durante la prima domenica della degenza. Al posto di Blanche si presenta un’altra infermiera a occuparsi di René Maugras. Questi è dapprima indispettito. E deluso per non essere stato preventivamente avvertito da Blanche. Ma riflettendo ha un insight: si rende improvvisamente conto che le cure che Blanche gli dedica vengono da una professionista. È pagata per il suo lavoro; ha anche una vita privata fuori del lavoro. Di tutto questo non deve rendere conto al suo assistito.
CIRCOSCRIVERE L’ATTIVITÀ DI CURA ENTRO I CONFINI DELLA PROFESSIONALITÀ
Circoscrivere l’attività di cura entro i confini della professionalità e sottoporla alle regole che sovrintendono ad essa è una tutela sia per il professionista che per il malato stesso. Questi sa che la cura professionale prescinderà dalle qualità personali di chi la riceve. Il malato può essere una persona rispettabile o spregevole, gradevole o scontroso, per non menzionare le sue opinioni politiche o la condizione sociale: il professionista si impegna a mettere tra parentesi tutte queste caratteristiche, vedendo in lui solo la persona che ha bisogno di cura. Ma anche il curante è tutelato dalla professionalità: ha impegni diversi rispetto al caregiver familiare (che per lo più non può staccare a un determinato orario o prendersi una domenica libera…). Il suo coinvolgimento emotivo è contenuto: per quanto si rallegri o si rattristi per gli esiti della terapia, ma non è legato a filo doppio con il malato come può esserlo un familiare.
Ciò che vincola il professionista al malato è stato tradizionalmente qualificato come “alleanza terapeutica”. Questa è fortemente asimmetrica: è proposta/concessa dal curante e accettata, con tutte le condizioni connesse, da chi riceve le cure. Il modello di alleanza terapeutica che il passato ci ha consegnato aveva un’impronta fortemente paternalistica. Basti un dettaglio: l’informazione non era dovuta al paziente. Assolutamente estranea, poi, l’idea di un diritto del paziente di essere informato, di essere coinvolto nelle decisioni terapeutiche, di dare un consenso esplicito ai trattamenti. Era il curante a decidere che cosa gli portava beneficio e a nascondergli ciò che, a suo giudizio, gli avrebbe nuociuto. Ciò giustificava silenzi, omissioni di informazioni, comunicazioni falsamente rassicuranti, bugie bianche e anche menzogne.
Questo è il tipo di rapporti nei quali il potente direttore di giornale, davanti al quale tutti a Parigi tremavano, si è venuto a trovare. In un momento ha visto la sua situazione capovolgersi: da “dominus” si sente trattato come un bambino. “Tra tutti c’è un grande scambio di sguardi. Naturalmente lui ne è escluso. Quello che avviene non lo riguarda, anche se avviene in lui, nel suo corpo”. Lo svolgersi, poi, della visita medica in reparto fa pensare a una cerimonia religiosa, con analoga ritualità; ancor più: ha aspetti di un gioco crudele da cui Maugras esce ulteriormente umiliato. L’ambientazione storica del romanzo – anni ’60 del secolo scorso – ci aiuta a contestualizzare un modo di esercitare la medicina che culturalmente va considerato superato. Verso la fine del ‘900 è stato finalmente riconosciuto il diritto di cittadinanza a quella svolta che Kant aveva prospettato ben due secoli prima come un cambio di passo per tutta la cultura. Nel saggio Che cos’è l’Illuminismo (1784) Kant definiva i tempi nuovi come l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve a sé stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Malgrado i cambiamenti che hanno progressivamente trasformato tutti gli aspetti della nostra società, la medicina ha continuato a essere praticata senza che i malati uscissero dalla minorità non dovuta, in forza della quale anche una persona adulta era trattata come un bambino, quando le fosse capitato di entrare nel territorio della malattia.
LA NUOVA CONDIZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ
Nella nuova condizione la professionalità ha subito una svolta: da pre-moderna è stata provocata a diventare moderna. La modernità qui evocata non è un semplice sinonimo di una situazione più aggiornata: è una medicina che ha affrontato una trasformazione epocale, equivalente a ciò che nella storia della scienza è chiamato cambio di paradigma. Moderna è la medicina quando è praticata con il malato, non su di lui. Parallelamente alla trasformazione dei rapporti tra professionisti – immaginiamo l’infermiera Blanche del nostro romanzo sollecitata ad abbandonare i tratti di surrogato materno per acquisire le caratteristiche di una professionista a tutto tondo; anche nei confronti dei medici, pur nella diversa professionalità – si attua anche una trasformazione della relazione tra i curanti e il malato. Nella modernità la buona cura prevede l’empowerment della persona malata. Ciò implica informazione corretta e onesta, coinvolgimento nel percorso terapeutico, condivisione delle scelte. Tutto ciò non era presente nell’orizzonte narrativo di Simenon, se non in forma di esigenza sentita sottopelle di un diverso modo di praticare la medicina. Il romanziere l’incarna nel disagio del protagonista per essere trattato in maniera paternalista dai professionisti sanitari. La trasformazione culturale non era lontana: avrebbe avuto luogo negli ultimi decenni del XX secolo, sotto la spinta del movimento della bioetica.
Una dimensione più alta della cura è invece esplicitamente formulata dal romanzo. Mentre nell’ospedale di Bicêtre i curanti – medici, infermieri, fisioterapisti – danno il meglio di sé stessi per riportare in efficienza l’illustre direttore, messo in ginocchio da un ictus, il lavorio interiore che si è svolto parallelamente al percorso di cura ha prodotto in Maugras una diversa consapevolezza. Friedrich Nietzsche l’avrebbe chiamata la possibilità di accedere alla Grande Salute: non semplicemente la salute di prima, ma uno stato diverso, che presuppone una crescita. Maugras si propone, anche dopo aver recuperato la prestanza fisica, di non vivere più come gli altri: “perché non è più del tutto uguale a loro e non tornerà mai più a esserlo”. Si è posto delle domande, che continuerà a tenersi dentro; domande che erano già lì, ma che il suo modo frenetico di vivere impediva loro di affiorare. Quei giorni di degenza, scanditi dal suono delle campane, hanno prodotto in lui una diversa consapevolezza e il desiderio di un cambiamento in profondità.
Questo almeno è il proposito che formula. Un romanzo dunque a lieto fine (in senso psicologico-spirituale)? Sotto l’abile penna di Simenon il cambiamento esistenziale rimane una possibilità, non un esito certo. Nelle ultime righe il romanzo descrive un René Maugras che dà segni di tornare a essere il direttore di giornale autoritario e iperattivo. A questo punto nella memoria del lettore riemergono due momenti che Maugras era andato rievocando nei giorni della sua afasia. Due istanti di perfetta felicità, non ottenuti volontariamente, ma caduti come un dono dall’alto: quella felicità gratuita che si riceve con totale innocenza. I cultori della psicologia umanistica e transpersonale li chiamerebbero peak experiences: momenti in cui siamo portati oltre il nostro Ego e ci si sente parte di un tutto che abbraccia: il Sé transpersonale, appunto. Stati alterati di coscienza, abbinati a un’estrema euforia e indescrivibile benessere, che generano una forma più avanzata di percezione della realtà. Aiutano le persone a entrare in contatto profondo con le qualità fondamentali della vita, delle quali siamo spesso inconsapevoli nel vissuto quotidiano. Per due volte – due sole volte nella vita – gli si è aperta la possibilità di una diversa autorealizzazione. Ebbene, rivocando quei momenti Maugras ricorda che ambedue le volte ha provato paura ed è tornato indietro. È questo lo scenario aperto con cui si conclude il romanzo: Maugras potrebbe procedere verso quella vita più autentica che la malattia gli ha fatto intravedere, oppure ritirarsi impaurito e rifugiarsi in quella esistenza che conosce bene, quella del successo e del potere, ma che non corrisponde all’uomo diversamente autorealizzato che potrebbe essere.
Per Blanche e tutti coloro che l’hanno accompagnato nel percorso di guarigione questa meta ultima – quella guarigione che non si limita a porre rimedio alla patologia, ma cambia il modo sbagliato e inconsapevole di vivere – è un obiettivo fuori della loro portata. La professionalità si arresta prima della Grande Salute. Fornisce l’ordito della cura; la trama – il disegno finale che ne è il prodotto – la disegna solo la persona coinvolta. Quando guarire equivale a cambiare vita, anche i curanti più volenterosi, anche quelli più abili, sanno di doversi tenere un passo indietro: nessuno può indurre in un’altra persona questa crescita, che è la nostra più alta possibilità. E personalissima responsabilità.