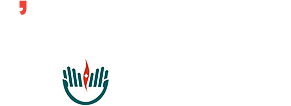Una lettura irrituale del nuovo Codice deontologico
Cosa si porta in questa stagione? E’ una domanda che può andar bene per i vestiti e le scarpe. Assolutamente fuori luogo per un codice deontologico: non si cambia perché è fuori moda. Anche se dalla redazione precedente sono passati dieci anni; così come, nel 2009, erano passati esattamente dieci anni dalla L. 42, che nel 1999 aveva abolito il mansionario e posto il Codice deontologico in una nuova prospettiva, determinando così la scelta della Federazione Ipasvi di rinnovarlo.
Non è difficile elencare le trasformazioni intervenute nell’ultimo decennio nella professione dell’infermiere e nell’organizzazione della sanità in generale. Le emergenze sono sotto gli occhi di tutti e le priorità – speriamo – nell’agenda di chi deve tenere a galla un Servizio Sanitario Nazionale che rischia di far naufragio. Ma per capire la necessità di riscrivere il Codice deontologico è più istruttivo mettere a fuoco dei cambiamenti intervenuti in profondità e non immediatamente percettibili. Qualcosa che assomiglia alla deriva dei continenti: ce ne accorgiamo solo quando provocano terremoti e sconvolgimenti. Con un po’ di enfasi possiamo affermare che la medicina, e più in generale la modalità di erogazione di cure professionali, deve affrontare un “cambio di paradigma”.
Con questa espressione si intende nella filosofia delle scienze una trasformazione che costringe a modificare dei punti di riferimento considerati tradizionalmente come assodati e indiscutibili. Il più celebre cambio di paradigma, a tutti noto, riguarda l’astronomia. Per più di un millennio è invalso il modello tolemaico. Questo considerava la terra immobile al centro dell’universo, mentre il sole le girava attorno. Proibito mettere in discussione il modello (chiedere a Galileo Galilei…). Finalmente, nel XVI secolo inoltrato, avviene la svolta di Copernico e il cambio di paradigma: è la terra che gira attorno al sole. Il sistema tolemaico riceve il benservito ed è messo in soffitta: l’astronomia diventa tolemaica.
Ebbene: qualcosa del genere ha avuto luogo in medicina. Con un’aggravante temporale: mentre il sistema tolemaico è stato elaborato nel secondo secolo della nostra era, il modello di cura al quale ci riferiamo affonda le radici nella medicina ippocratica. Elaborato nel V secolo avanti Cristo, è durato fino ai nostri giorni. Una durata inaudita, che non ha l’analogo in nessun altro sistema di valori destinato a strutturare la nostra convivenza. Naturalmente ci riferiamo ai valori etici che ne costituiscono la struttura profonda del rapporto di cura, non alle teorie esplicative delle patologie e ai rimedi ai quali si fa ricorso. Mentre queste sono periodicamente state messe in discussione e aggiornate, l’etica medica – ammantata con il giuramento di Ippocrate – non è mai cambiata. Fino alla transizione avvenuta sotto i nostri occhi. Il medico rinascimentale che disponeva solo di salassi e clisteri e quello dei nostri giorni che si muove tra TAC e farmaci biologici hanno in comune la stessa modalità di concepire la cura e il rapporto che li lega a chi ne beneficia. A meno che non intervenga un cambiamento del plurisecolare paradigma. Ed ecco che, accanto ai tolemaici, in medicina si affacciano i copernicani.
Come si differenziano i due modelli? In buona sostanza, per i tolemaici-ippocratici la buona cura viene decisa dal medico, “in scienza e coscienza”. Il medico acquisisce con lo studio un sapere che lo qualifica a stabilire qual è il bene del paziente e lo persegue, tenendo lontano – con “coscienza” – interferenze che potrebbero portarlo nel terreno di interessi illegittimi. Il medico è il “dominus” della cura. Il bene del paziente è il suo obiettivo, e il medico lo conosce come nessun altro. Meglio del paziente stesso. “Non pretenderà di sapere lei che cosa è meglio per lei”: è la frase che una paziente riportava all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di un’azienda sanitaria per lamentarsi del proprio medico. Un medico esplicitamente e candidamente tolemaico, che intendeva disinnescare così ogni aspirazione della paziente a interferire con il trattamento.
In questo modello di rapporto, il medico non ha, al limite, bisogno dell’intervento del malato: a questi chiede di portare il suo bisogno di salute, al quale cercherà di rispondere al meglio delle possibilità che gli fornisce l’organizzazione. Il paziente fa il suo mestiere di “paziente” (lo dice la parola stessa…). “Lei è in ospedale per guarire, non per far domande”: con questa frase un primario era solito scoraggiare le richieste di informazioni dei malati sul loro stato di salute.
Un altro tratto del modello era la gerarchizzazione dei ruoli: a fronte della funzione dominante del medico, le altre professioni erano considerate sussidiarie. Il mansionario costringeva l’infermiere in un ambito delimitato, e allo stesso tempo lo proteggeva dalle possibili prevaricazioni.
Il passaggio al modello che chiameremmo, per analogia, copernicano è stato promosso dal movimento della bioetica, che ha preso forma negli ultimi decenni del XX secolo. Un indicatore eloquente: il ruolo attribuito all’informazione al paziente. Stiamo parlando dell’informazione vera, con parole oneste, non di quella con frasi rassicuranti o francamente menzognere (“Al medico si conviene la bugia pietosa”, canta Violetta nella Traviata, quando il medico cerca di confortare la morente promettendole pronta guarigione…). Mentre nella medicina tradizionale è il medico che valuta se è bene o no che il paziente conosca diagnosi e prognosi – informazioni eventualmente scambiate con i familiari, alle spalle del paziente – nel nuovo modello è un diritto del cittadino malato essere informato. Il cambiamento è stato registrato nel Codice deontologico dei medici italiani solo nella revisione del 1995. Perché nelle loro norme deontologiche i medici hanno attuato il passaggio al nuovo paradigma, senza che ciò comporti che tutti i medici se ne siano resi conto.
Sottostante al cambiamento c’è un ruolo diverso del malato: non riceve più solamente la cura che il medico decide in scienza e coscienza, ma la struttura insieme al professionista. E’ chiamato ad essere consapevole e partecipante. Il professionista non ha più tutto il sapere. Certo, deve avere la “scienza”; ma questa è solo la metà di ciò che è necessario conoscere nel processo di cura. A fronte delle conoscenze scientifiche del medico, sta ciò che “sa” la persona malata, ovvero le proprie preferenze, i propri valori, la concezione individuale di qualità della vita. In una parola, di fronte alla scienza, sta il vissuto. Se il professionista non ascolta la persona malata – nota bene: un ascolto che logicamente e cronologicamente precede l’informazione! – non potrà conoscere qual è la cura appropriata. La cura personalizzata: ecco, in sintesi, la svolta copernicana nell’arte della cura.
A questo punto bisogna aggiungere che il cambiamento auspicato è trasversale: coinvolge sia i professionisti che i cittadini. Ci sono professionisti sanitari che non hanno alcuna intenzione di lasciare la culla tolemaico-ippocratica in cui sono cresciuti. Ma anche cittadini che preferiscono affidarsi: per loro il medico è l’unico che sa e che può; non vogliono essere coinvolti nelle decisioni. Richard Smith, direttore del British Medical Journal, ha evocato per questo atteggiamento la qualifica psichiatrica di “folie à deux”… C’è connivenza tra la follia del medico che pretende di sapere tutto ciò che è necessario per la cura, tenendo fuori il vissuto del malato, e la follia del malato che rinuncia alla consapevolezza, all’informazione e al coinvolgimento nella ricerca di una cura “sartoriale”, preferendo affidarsi passivamente.
Il cambiamento inoltre richiede tempo per diventare parte vitale della cultura. Ci chiediamo: quanto tempo è stato necessario perché gli astronomi abbandonassero il modello consolidato della centralità immobile della terra? D’altra parte non mancano anche oggi i “terrapiattisti” (non tra gli astronomi, speriamo…). Ancor più tempo sarà in ogni caso necessario per la transizione al nuovo paradigma della cura, che richiede un profondo cambio culturale. Alcuni, tra i professionisti e tra i cittadini, non hanno avvertito il cambiamento. E non sembrano intenzionati a farlo. Altri invece sono cambiati troppo, prendendo strade fuorvianti, che portano lontano dalla modalità di cura condivisa. E’ lo scenario che vede medici radicalmente “autonomisti”: fanno scegliere al paziente e tutt’al più si mettono in posizione di sicurezza con la modulistica del consenso informato (“Paziente informato, medico salvato”!). Non meno lontani dal modello della buona cura sono i cittadini prevaricatori, che hanno deciso che ormai il sapere (?) che attingono da internet sia loro sufficiente e chiedono solo ai professionisti di essere esecutori delle loro autoprescrizioni di terapia.
Rendere operativo il modello della buona cura, assimilando il cambiamento culturale che nasce dai nuovi ruoli dei curanti e delle persone in cura, è impresa ardua. Affiora a questo punto la domanda cruciale: a quale modello si ispira il nuovo Codice deontologico che gli infermieri hanno licenziato dopo lunga deliberazione? Ovvero: è consapevole del cambiamento del paradigma in atto e l’ha sposato? In breve: è un Codice tolemaico o copernicano?
E’ questo confronto, con le domande che corrono sottopelle nel rapporto di cura, che rende rilevante un codice deontologico. Impedendogli di degradare in un’arida raccolta di norme, in un catalogo di prescrizioni. La relazione che si instaura tra colui che riceve le cure e il professionista che le eroga, nonché tra i diversi professionisti tra di loro, è il cuore pulsante di un codice deontologico. Equivale a esplicitare le “regole del gioco”. Ed è assolutamente cruciale confrontarsi con le regole, in un’epoca di cambiamento: perché le modalità di relazionarsi con il terapeuta nell’uno e nell’altro scenario sono radicalmente diverse.
Un codice deontologico, prima di qualsiasi altra finalità, ha il compito di rispondere a questi interrogativi. I professionisti – gli infermieri in questo caso – hanno bisogno di collocarsi sulla scena della cura, prendendo posizione consapevolmente per l’uno o l’altro modello. E coloro che alle loro cure fanno ricorso hanno diritto di sapere in quale modello i professionisti si riconoscono. Anche se la deontologia ha punti di interferenza sia con la legge che con l’etica, non si identifica né con l’una, né con l’altra. La sua specificità è di mettere a fuoco la relazione di cura.
Non c’è dubbio che nel ventennio che hanno alle spalle, e nelle successive tre rielaborazioni del proprio Codice deontologico, gli infermieri italiani hanno fatto una transizione esplicita verso il modello di cura della modernità. Sia nel rapporto con chi riceve le cure – evidenziando la necessità che il professionista infermiere ascolti, si prenda il tempo per la comunicazione, si confronti con le scelte etiche che non condivide, perché la nostra struttura sociale prevede la compresenza di “stranieri morali” – sia con gli altri professionisti con cui condivide la responsabilità della cura, secondo rapporti non più di subordinazione gerarchica.
Nessuna innovazione nella rotta: la navigazione continua in maniera decisa, lasciando alle spalle i rapporti che la cultura del nostro tempo ha delegittimato. Potrebbe esser molto proficua una rilettura del nuovo Codice collocando i diversi articoli sullo sfondo dei due modelli contrapposti, “tolemaico” o “copernicano”. Un esercizio che gli infermieri potrebbero essere invitati a fare insieme, nel processo di ricezione del Codice. Ciò potrebbe portarli ad acquistare consapevolezza che il nuovo Codice, nel quale si riconoscono, è molto, molto di più di una raccolta di proclami altisonanti. E’ la carta d’identità dell’infermiere in quanto professionista; contiene il patto implicito che gli infermieri intendono stabilire con il cittadino che ricorre alle loro cure. Nessun cambio per motivo di moda, dunque, ma una sempre più consapevole adesione al modello di buona medicina. Così come il nostro tempo la pretende.