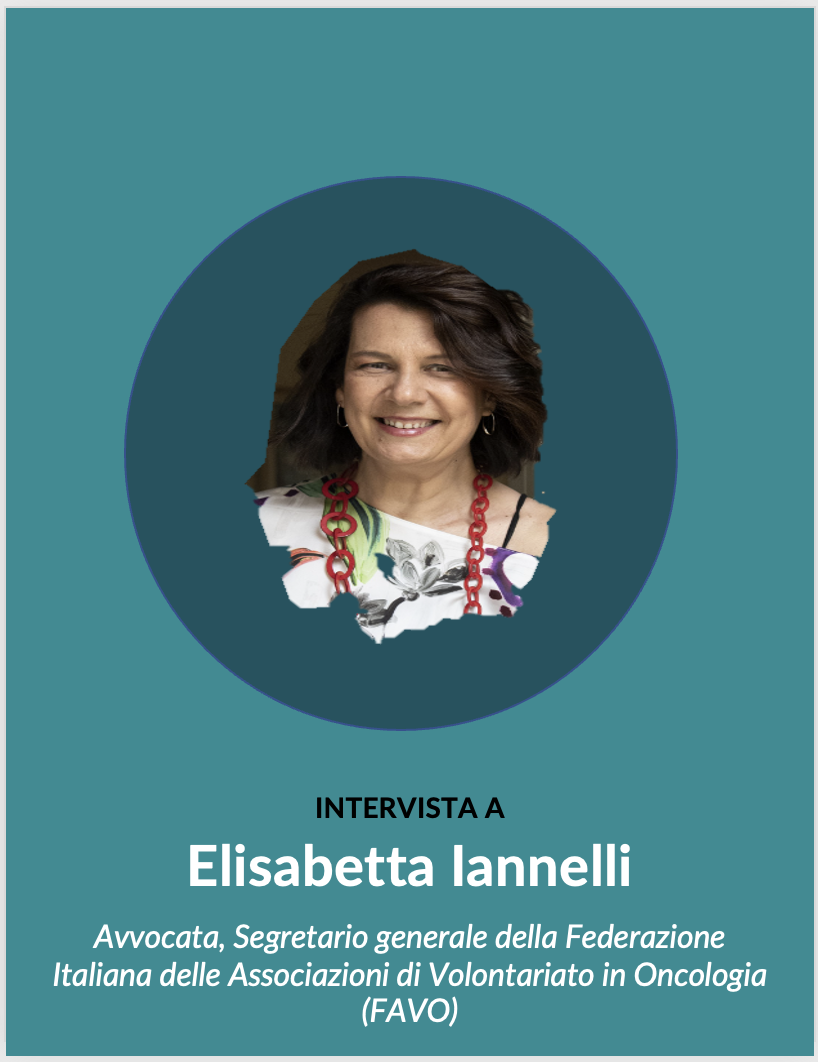L’allattamento al seno è oggi riconosciuto come un vero e proprio determinante di salute. Ne abbiamo parlato con i colleghi della Commissione Nazionale d’Albo Infermieri Pediatrici.
Quale impatto ha sulla salute?
Diminuisce il rischio di sviluppare malattie infettive, metaboliche e cronico-degenerative, sia nel bambino che nella madre, contribuendo in modo significativo alla promozione della salute pubblica e alla riduzione dei costi sanitari. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda l’allattamento esclusivo per i primi sei mesi di vita, con prosecuzione fino ai due anni e oltre. Tuttavia, il momento della dimissione ospedaliera rappresenta una fase critica: molte madri si trovano improvvisamente prive del supporto clinico ricevuto durante il ricovero, con il rischio di interrompere precocemente l’allattamento. Secondo l’UNICEF, nel mondo solo il 48% dei neonati viene allattato esclusivamente nei primi sei mesi di vita. Secondo l’UNICEF, nel mondo solo il 48% dei neonati viene allattato esclusivamente nei primi sei mesi di vita In Italia, il tasso di allattamento esclusivo a tre mesi è del 47,5%, mentre a sei mesi scende al 30,3%. Le differenze regionali sono significative: in alcune aree del Sud Italia, il tasso di allattamento esclusivo a sei mesi è inferiore al 20% (Istituto Superiore Sanità-Epicentro, Sistema Sorveglianza 0-2 anni, indagine 2022).
Per rendere effettive le raccomandazioni internazionali sull’allattamento cosa è necessario fare?
È necessario che esse si innestino su una rete di supporto territoriale capace di accompagnare la famiglia anche dopo la dimissione ospedaliera. Nel 2022 l’OMS ha pubblicato 63 Raccomandazioni per favorire un’esperienza post-natale sicura e positiva, tra cui il timing dei controlli post-natali e la promozione del sostegno attivo dei padri, in considerazione che le prime sei settimane di vita (42 giorni), sono un momento critico per le donne, i neonati, i partner, i genitori, chi si prende cura del bambino e le famiglie.
In questo contesto, le Professioni Infermieristiche assumono un ruolo centrale, che si estende nei luoghi della quotidianità: consultori familiari, servizi educativi, ambulatori territoriali e spazi comunitari. È in questi ambienti che il contatto diretto con donne in gravidanza, madri e bambini consente di attuare buone pratiche assistenziali, finalizzate alla protezione e promozione della fisiologia della nascita, all’avvio e alla prosecuzione dell’allattamento, nonché al rafforzamento del legame genitoriale.
Tra le problematiche più comuni si riscontrano ragadi, ingorghi mammari, dubbi sulla quantità di latte prodotto e timori legati al rientro al lavoro. L’intervento infermieristico, in sinergia con altri professionisti della salute, contribuisce a costruire un contesto favorevole alla salute materno-infantile, basato su ascolto, competenza e continuità assistenziale. La collaborazione rappresenta un valore aggiunto per garantire continuità assistenziale e qualità dell’intervento.
Un ulteriore elemento strategico per la promozione dell’allattamento è la consapevolezza dei diritti delle famiglie. In diverse regioni italiane, è previsto il diritto di portare il latte materno nei servizi educativi per la prima infanzia, come i nidi. Tuttavia, questa possibilità è ancora poco conosciuta e scarsamente valorizzata.
La sostenibilità dell’allattamento, non può prescindere dalla considerazione del benessere psicologico della madre e del padre. Il periodo post-partum rappresenta una fase di particolare vulnerabilità, durante la quale possono manifestarsi sintomi di disagio emotivo quali ansia, tristezza, irritabilità e senso di inadeguatezza.
È essenziale che il personale infermieristico sia formato per attivare tempestivamente la rete territoriale di supporto — composta, tra gli altri, da psicologi, medici di medicina generale e servizi sociali — e per promuovere una cultura della cura che includa anche la dimensione emotiva e relazionale della genitorialità.
La letteratura scientifica evidenzia come il sostegno all’allattamento, se integrato con interventi di supporto psicologico, contribuisca a ridurre il rischio di depressione post-partum e a migliorare gli esiti di salute per tutta la famiglia.
E i falsi miti…
L’allattamento è un tempo speciale, che racchiude spesso incertezze, difficoltà e non pochi miti da sfatare: è necessario infatti, per aiutare le madri e le famiglie, a vivere questo tempo con serenità, superare tutte quelle affermazioni che sono frutto di credenze popolari e prive di fondamenti scientifici. Le “fake science” più diffuse sull’allattamento dopo i primi giorni:
- “Il latte materno non è più sufficiente dopo i primi mesi” o “Dopo i sei mesi il latte materno diventa acqua”, è una credenza senza alcun fondamento scientifico. Il latte materno si adatta nel tempo alle esigenze nutrizionali del bambino, mantenendo un profilo ricco di nutrienti, anticorpi e fattori bioattivi anche dopo i primi mesi di vita. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento esclusivo fino a sei mesi e il proseguimento, insieme ad alimenti complementari, fino a due anni e oltre.
- “Se la mamma rientra al lavoro, deve interrompere l’allattamento”, una frase che può allontanare le donne dal rientro al lavoro o che può portare ad una interruzione precoce dell’allattamento non necessaria. È possibile continuare ad allattare grazie a strategie come la spremitura e conservazione del latte materno, l’allattamento a richiesta nei momenti disponibili e il supporto dei servizi educativi che accettano il latte materno. Informare le famiglie su queste possibilità favorisce la prosecuzione dell’allattamento anche dopo la dimissione.
- “Se la mamma ha il raffreddore o la febbre, deve sospendere l’allattamento”, è una falsa credenza. Nella maggior parte dei casi, le infezioni comuni non richiedono la sospensione dell’allattamento. Continuare ad allattare durante una malattia permette al bambino di ricevere anticorpi specifici attraverso il latte materno, contribuendo a rafforzare il suo sistema immunitario.
- “Se il bambino piange spesso, significa che il latte materno non basta”, una frase che, anche se detta con semplicità, può avere un impatto emotivo devastante sulla psiche di una mamma che allatta. Il pianto del neonato non è sempre correlato alla fame o ad una carenza di latte. E’ innanzitutto l’unico modo che ha il neonato per comunicare alla madre che necessità di più latte e quindi stimolare il corpo materno, come avviene fisiologicamente nelle settimane di “scatto di crescita”. Inoltre il pianto può essere espressione di molteplici bisogni (contatto, disagio, stanchezza). La valutazione della crescita e del benessere del bambino è il parametro più affidabile per verificare l’adeguatezza dell’allattamento.
Perché i sistemi siano sostenibili le professioni infermieristiche devono stare sul territorio?
Si, tra le iniziative più significative per il sostegno all’allattamento nel contesto familiare e comunitario, si distingue il programma “Comunità Amica dei Bambini e delle Bambine” (BFCI – Baby Friendly Community Initiative), promosso da UNICEF Italia. Questo modello nasce dall’adattamento territoriale dell’Iniziativa “Ospedale Amico dei Bambini” (BFHI – Baby Friendly Hospital Initiative), con l’obiettivo di estendere i principi della promozione dell’allattamento ai servizi socio-sanitari locali e alla comunità.
La BFCI si fonda sulla consapevolezza che l’allattamento non è solo una scelta individuale, ma un diritto del bambino a ricevere la migliore alimentazione possibile per la propria età, come sancito dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Il programma promuove una rete di sostegno continuativa per genitori e bambini, basata sulla collaborazione tra i punti nascita, i servizi territoriali, i gruppi di sostegno e le realtà associative.
Promuovere e sostenere l’allattamento nel periodo successivo alla dimissione ospedaliera significa prendersi cura della famiglia nella sua globalità. Significa garantire accesso a strumenti informativi validati, offrire ascolto competente e presenza professionale, e accompagnare le madri e i padri in un percorso che, pur essendo naturale, richiede supporto, fiducia e continuità.
Attraverso interventi educativi, clinici e relazionali, il personale infermieristico può contribuire a rendere l’allattamento una scelta consapevole, sostenibile e integrata nella vita quotidiana.
Sostenere l’allattamento oltre le mura ospedaliere non è solo un atto clinico: è un gesto di responsabilità sociale, un investimento sulla salute pubblica e una dichiarazione di fiducia nelle competenze genitoriali. È nel territorio che l’allattamento trova il suo spazio più fragile e più autentico.
E in questo spazio, anche le Professioni Infermieristiche sono protagoniste competenti, attive e protagoniste accanto a madri e bambini.
Quali sono azioni che trasformano l’allattamento da scelta individuale a diritto collettivo?
Essere presenti, informare, ascoltare, accompagnare perché ogni madre che allatta sostenuta è una famiglia che cresce protetta e ogni professionista sanitario che interviene è un ponte tra la scienza e la vita quotidiana.
Per approfondire
- World Health Organization (2023). Infant and young child feeding. Geneva: WHO. Disponibile su: WHO Fact Sheet
- Epicentro – Istituto Superiore di Sanità (2022). Indagine nazionale sull’allattamento al seno. Roma: ISS. Disponibile su: Epicentro – Documentazione Italia
- UNICEF Italia (2025). Comunità Amica dei Bambini e delle Bambine – BFCI. Roma: UNICEF. Disponibile su: UNICEF Italia – BFCI
- Ministero della Salute (2008). Linee di indirizzo nazionale sulla promozione, protezione e sostegno dell’allattamento al seno. G.U. n. 32 del 7 febbraio 2008. Disponibile su: Ministero della Salute – Linee guida
- The Lancet (2023). Breastfeeding Series. London: The Lancet Publishing Group. Disponibile su: The Lancet – Breastfeeding 2023
- CDC – Centers for Disease Control and Prevention (2023). Proper Handling and Storage of Breast Milk. Atlanta: CDC. Disponibile su: CDC Guidelines
- SIGO, AOGOI, AGUI (2018). Linee guida sulla nutrizione in gravidanza e durante l’allattamento. Fondazione Confalonieri Ragonese. Disponibile su: SIGO – Nutrizione e Allattamento
7 ottobre 2025