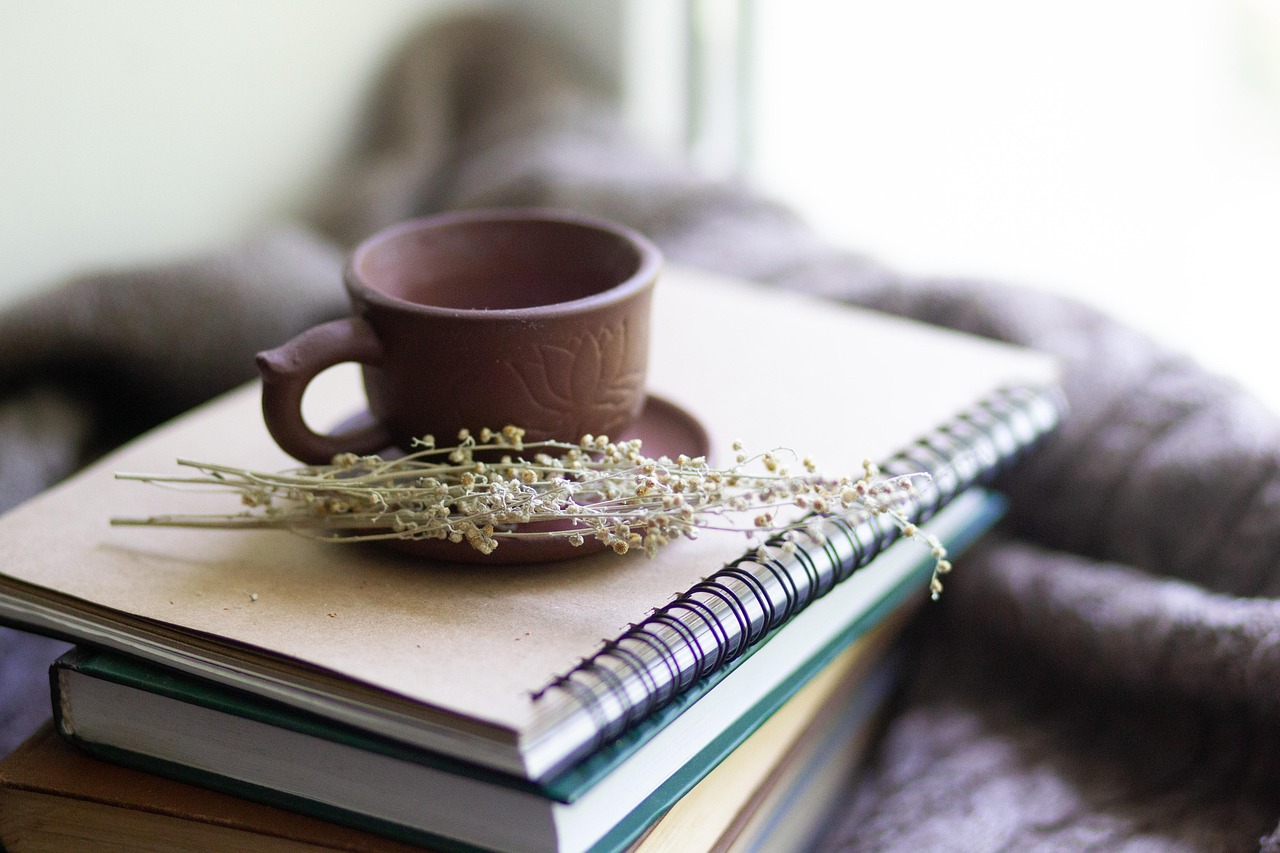INTRODUZIONE
La cartella informatizzata consente di pianificare e valutare gli interventi assistenziali, documentare le azioni e comunicare tra professionisti, sia all’interno delle strutture di cura che tra diverse strutture ospedaliere e territoriali. La documentazione della pianificazione infermieristica rappresenta un elemento cruciale per garantire continuità e qualità delle cure, oltre a favorire la sicurezza del paziente e supportare le decisioni cliniche. Con l’espansione delle tecnologie digitali e delle iniziative di e-Health, diventa sempre più importante adottare sistemi standardizzati che permettano una comunicazione coerente tra i professionisti della salute e una raccolta dati robusta per l’analisi secondaria che supporti le decisioni organizzative. Le terminologie standardizzate e codificate, con l’enunciazione delle cosiddette diagnosi infermieristiche, consentono la presa in carico dei bisogni assistenziali delle persone assistite e delle loro famiglie, valorizzando e rendendo tangibile il lavoro quotidiano dei professionisti. Anche la FNOPI raccomanda l’adozione delle terminologie infermieristiche standardizzate (SNTs), riconosciute a livello internazionale, per migliorare la qualità, la visibilità e l’efficacia dell’assistenza infermieristica, uniformare la pratica clinica, ottimizzare le risorse e favorire formazione, ricerca e integrazione nei sistemi informativi sanitari (Mazzoleni e Ausili et al., 2018). L’introduzione della documentazione elettronica richiede l’uso di linguaggi omogenei. Il dibattito su potenzialità e limiti dei Standardized Nursing Languages – SNLs è ancora aperto e richiede una riflessione tra ricercatori, formatori, clinici e coordinatori/dirigenti delle cure infermieristiche rispetto alle scelte da operare (Visintini e Chiappinotto et al., 2024).
Negli ultimi 15 anni, in Italia, si è sviluppato un crescente interesse verso l’adozione di terminologie infermieristiche standardizzate nella formazione, nella pratica clinica, nella ricerca e nell’organizzazione. L’ultima indagine disponibile condotta a livello nazionale sull’utilizzo delle SNTs risale al 2018, coinvolgendo 145 centri tra sedi universitarie e contesti clinici (Mazzoleni e Ausili et al., 2018). I risultati indicavano che l’87% dei Corsi di Laurea in Infermieristica e il 46% delle Direzioni delle Professioni Sanitarie utilizzano almeno una SNT, North American Nursing Diagnosis Association International (NANDA-I), Nursing Outcomes Classification (NOC) e Nursing Interventions Classification (NIC) tra le più diffuse, anche se emergeva una notevole variabilità nei modelli teorici e organizzativi adottati. La diffusione delle SNTs in Italia è paragonabile a quella di altri Paesi, ma si evidenzia la necessità di linee guida condivise e ulteriori studi per superare le criticità, mettere in rete le esperienze locali di successo e promuoverne l’uso efficace nella pratica e nella formazione. A tal proposito, l’interoperabilità dei dati rimane ancor oggi uno dei principali ostacoli alla diffusione sistematica e capillare delle terminologie standardizzate, e alla loro comparazione su scala nazionale in termini di esiti. Pertanto, nonostante i benefici noti, molti passaggi della documentazione infermieristica risultano ancora frammentati, non permettendo di fatto l’istituzione di un flusso informatico nazionale e compromettendo la consistenza dei dati raccolti.
INQUADRAMENTO GENERALE
Secondo l’OMS, il linguaggio standardizzato è un insieme di termini condivisi con definizioni precise utilizzati nella valutazione, gestione e cura dei pazienti, collegati a sistemi di codifica e classificazione. In ambito infermieristico, questi linguaggi organizzano e codificano in modo sistematico l’assistenza, facilitando una comunicazione chiara della pratica, la progettazione di modelli di cura personalizzati, la pianificazione delle risorse da parte delle amministrazioni sanitarie e una quantificazione accurata dei costi dell’assistenza (WHO, 2006). L’American Nurses Association (ANA) identifica tre criteri fondamentali per il riconoscimento di un set di dati infermieristici: la forza della terminologia utilizzata, che garantisce coerenza e precisione; la rintracciabilità e il rigore nello sviluppo e nell’aggiornamento dei contenuti, assicurando affidabilità e attualità; e la capacità del set di dati di dimostrare un valore aggiunto concreto, contribuendo al miglioramento della pratica infermieristica e dei risultati assistenziali (Dochterman e Jones, 2003; Jones e Lunney et al., 2010). Attualmente, l’ANA riconosce dodici SNTs, ciascuna sviluppata con un proprio scopo, struttura concettuale e, in molti casi, un solido quadro teorico di riferimento. Le terminologie più diffuse a livello internazionale, come anche in Italia, sono NANDA-I, NIC e NOC, le quali costituiscono il cosiddetto sistema NNN (D’Agostino e Tuinman et al., 2024). Queste tre tassonomie, sviluppate principalmente presso la University of Iowa, si basano sul modello funzionale della salute di Gordon per la raccolta dati e la formulazione delle diagnosi infermieristiche (Herdman e Kamitsuru, 2014). L’ICNP™ (International Classification for Nursing Practice), sviluppata dal Consiglio Internazionale degli Infermieri (International Council of Nurses – ICN), ha un impianto teorico fondato su un approccio ontologico e concettuale globale della pratica infermieristica (Coenen, 2003; Moorhead e Swanson et al., 2018). La Clinical Care Classification (CCC) e l’Omaha System, invece, si fondano su modelli teorici integrati di documentazione e processo assistenziale e sono particolarmente adatti per l’integrazione con sistemi informativi elettronici (Martin, 2005; Zeffiro e Sanson et al., 2021). Il Perioperative Nursing Data Set (PNDS) si basa sulla pratica clinica in ambito perioperatorio ed è sostenuto dalle linee guida della Association of periOperative Registered Nurses (AORN). L’Home Health Care Classification (HHCC), in ultimo, è specificamente orientato all’assistenza domiciliare e segue un impianto teorico-pratico centrato sulle necessità funzionali. Delle dodici nomenclature, solo nove sono mappate nel sistema internazionale di terminologia clinica Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms (SNOMED CT), tra cui NANDA-I, NIC, NOC, ICNP, CCC, Omaha, PNDS, HHCC, e Loinc® (in parte). I linguaggi codificati garantiscono l’interoperabilità semantica e l’integrazione nei sistemi informativi sanitari, rendendo possibile una documentazione infermieristica codificata, confrontabile e utile per la ricerca, la governance e la qualità dell’assistenza. Tuttavia, anche in questo senso permangono dei limiti in termini di fruibilità linguistica.
CONTESTO
La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (FTGM) è un ente pubblico del Servizio Sanitario Regionale della Toscana, specializzato nella diagnosi, cura e ricerca delle patologie cardiovascolari e polmonari. Opera attraverso due strutture ospedaliere: l’Ospedale del Cuore “G. Pasquinucci” di Massa e l’Ospedale San Cataldo-CNR di Pisa. La Fondazione è un centro di riferimento nazionale e internazionale per la diagnosi e la cura delle patologie cardiovascolari e polmonari, incluse malattie rare come le cardiopatie congenite, l’ipertensione polmonare, l’amiloidosi cardiaca e le dislipidemie familiari. Ogni anno la FTGM gestisce oltre 1200 interventi cardiochirurgici, nella popolazione adulta e pediatrica.
In termini di informatizzazione dei dati, in Fondazione, il percorso inizia già dai primi anni 2000 con lo sviluppo di una cartella clinica medica. I primi sviluppi della cartella infermieristica informatizzata (modulo Nurse) risalgono a gennaio 2013 e la sperimentazione ha avuto inizio a gennaio 2014. Il modulo Nurse ha sostituito il Sistema di Gestione Infermieristica di Reparto (SGIR), operativo dal 1998, consentendo una sistematizzazione dei dati di interesse infermieristico. Nel 2015 i primi dati digitalizzati riguardavano la rilevazione dei parametri vitali, le valutazioni multidimensionali e la somministrazione terapeutica. Dal 2019, è stato poi avviato un progetto per l’implementazione del linguaggio ICNP™ e dei nomenclatori SNOMED CT, integrando il processo assistenziale specifico dell’area cardiovascolare, con la compilazione assistita delle scale raccomandate dall’accreditamento regionale e con gli standard Joint Commission International (JCI) con cui la Struttura si è certificata. Il Progetto, che ha richiesto uno sviluppo pluriennale, ha visto la costituzione di un gruppo di lavoro disciplinare integrato Pisa-Massa in stretta collaborazione con l’Unità Operativa Complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, incontri formativi e operativi presso il Centro Italiano per la Ricerca e lo Sviluppo ICNP™ (Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Milano Bicocca), l’adesione al network ICNP™ per lo sviluppo di Catalogue Subset monospecialistici, l’adattamento contestuale degli stessi, supportando lo sviluppo informatico di un prodotto certificato di digitalizzazione del processo assistenziale denominato Processo di Nursing Integrato – PNI. Il PNI è costituito da quattro moduli complementari: (1) valutazione dei bisogni assistenziali secondo l’approccio ABCDEF (Airways, Breathing, Circulation, Disability, Exposure, Family environment; quest’ultimo in fase di sviluppo), (2) attivazione delle diagnosi infermieristiche, (3) pianificazione dei relativi interventi clinico-assistenziali e (4) outcome da raggiungere. Le sezioni enunciate sono interoperabili con i restanti moduli della cartella. Infine, i problemi collaborativi attivi convergono nella sezione riepilogativa “indicazioni clinico-assistenziali” per un handover strutturato con metodo ISBAR-modificato, il cui sviluppo è già stato pubblicato altrove, promuovendo una presa in carico sicura e consapevole (Speltri e Vaselli et al., 2021).
Ad aprile 2024 è stato avviato il processo di implementazione del modulo PNI con la formazione dei professionisti a distanza (FAD), on the job e attività di tutoring nei setting assistenziali. Da giugno 2024, gli infermieri delle terapie intensive e delle aree di degenza per l’utenza adulta hanno avviato la sperimentazione. Lo sviluppo del modulo informatico per la popolazione pediatrica è ancora in corso di definizione con la collaborazione di un gruppo di lavoro interaziendale con altri enti di natura pediatrica.
OBIETTIVI
Migliorare la tracciabilità e la qualità dei dati infermieristici e misurare gli esiti sensibili all’assistenza infermieristica in area cardiovascolare. Descrivere le diagnosi infermieristiche attivate e gli interventi registrati.
RISULTATI
Ad una prima estrazione dei dati da giugno a dicembre 2024, sono stati accettati n. 3786 pazienti di cui ascrivibili al PNI in regime di ricovero n. 2848, per un totale di n. 41659 valutazioni infermieristiche con una media di giornate di degenza pari a 11.8 (± 13.5). A tal proposito, l’analisi di correlazione di Pearson ha evidenziato una relazione positiva moderata tra il numero di giornate di degenza e il numero di valutazioni infermieristiche effettuate, con un coefficiente r pari a 0.399, suggerendo che all’aumentare della durata del ricovero, tendano ad aumentare anche il numero di valutazioni infermieristiche, probabilmente perché i pazienti sono anche più complessi. La correlazione risulta statisticamente significativa (p < 0.001; gdl = 2846). Le diagnosi infermieristiche prevalenti includono la condizione più registrata che è quella di allettamento con 1.295 attivazioni, seguita dal deficit di autocura (1.093) e dalla compromissione della funzione urinaria (756). Anche i rischi di compromissione del sistema respiratorio (743 attivazioni) e la compromissione del cammino (636) risultano rilevanti. In misura minore, ma comunque significativa, emergono problematiche legate al rischio nutrizionale (454) e al monitoraggio della compliance al regime idrico (383). Queste suggestioni preliminari forniscono già molte informazioni sulle caratteristiche degli assistiti e sulla complessità assistenziale in maniera indiretta. I risultati preliminari indicano inoltre le attività svolte maggiormente dal personale infermieristico, di fatto fornendo informazioni in merito alla tangibilità dell’assistenza. I dati identificano la prevenzione delle ulcere da pressione al primo posto (1.942 attivazioni), sottolineando l’attenzione al rischio di lesioni da decubito nei pazienti a mobilità ridotta. Seguono attività strettamente correlate alla mobilizzazione e all’igiene del paziente, come il posizionamento, verosimilmente per le attività procedurali di natura cardiochirurgica o emodinamica (1.295 attivazioni), e l’assistenza all’igiene personale a vari livelli di supporto: igiene orale (1.093), bagno (1.092) e facilitazione dell’igiene personale (1.092). L’esecuzione dell’emogasanalisi arteriosa, coerente con il focus cardiovascolare, vede 1.124 attivazioni. Dal lato più manageriale si denotano sicuramente miglioramenti nella completezza e chiarezza della documentazione infermieristica, in virtù della definizione di un sistema di passaggio delle informazioni meno soggetto a manipolazioni o errori di trascrizione delle informazioni tra diversi interlocutori, anche in coerenza con gli standard JCI. È possibile infine supporre che questo abbia migliorato la presa in carico dei bisogni assistenziali e abbia favorito un approccio multiprofessionale.
CONCLUSIONI
Questo progetto prospetta i numerosi e potenziali vantaggi di un approccio strutturato e basato su terminologie standardizzate per documentare l’assistenza infermieristica. L’iniziativa ha dimostrato come questo possa migliorare la qualità delle cure e supportare la pratica anche informando il management. Tuttavia, queste suggestioni potranno essere ancor più determinanti in un’analisi per setting assistenziale pianificata a dodici mesi dal termine dell’implementazione. Infine, è in costruzione una dashboard di monitoraggio degli esiti del PNI come strumento strategico. Ci si auspica che, come accade già per altri Paesi (Ng e Tan, 2021), anche in Italia sistemi di digitalizzazione delle informazioni riguardanti l’attività infermieristica possano essere utilizzati per informare i decisori politici.
Conflitto di interessi
Si dichiara l’assenza di conflitto di interessi. Tutti gli autori dichiarano di aver contribuito alla realizzazione del manoscritto e ne approvano la pubblicazione.
Finanziamenti
Gli autori dichiarano di non avere avuto alcuna forma di finanziamento.
Ringraziamenti
Gli Autori ringraziano i Professionisti delle Unità Operative di Pisa e Massa, implicate nel progetto di implementazione del linguaggio ICNP™, per l’impegno costantemente profuso, la Direzione Aziendale per aver supportato il processo di implementazione e consolidamento, e il Centro Italiano per la Ricerca e lo Sviluppo ICNP™ per la stretta collaborazione e i continui interscambi nelle diverse fasi progettuali.