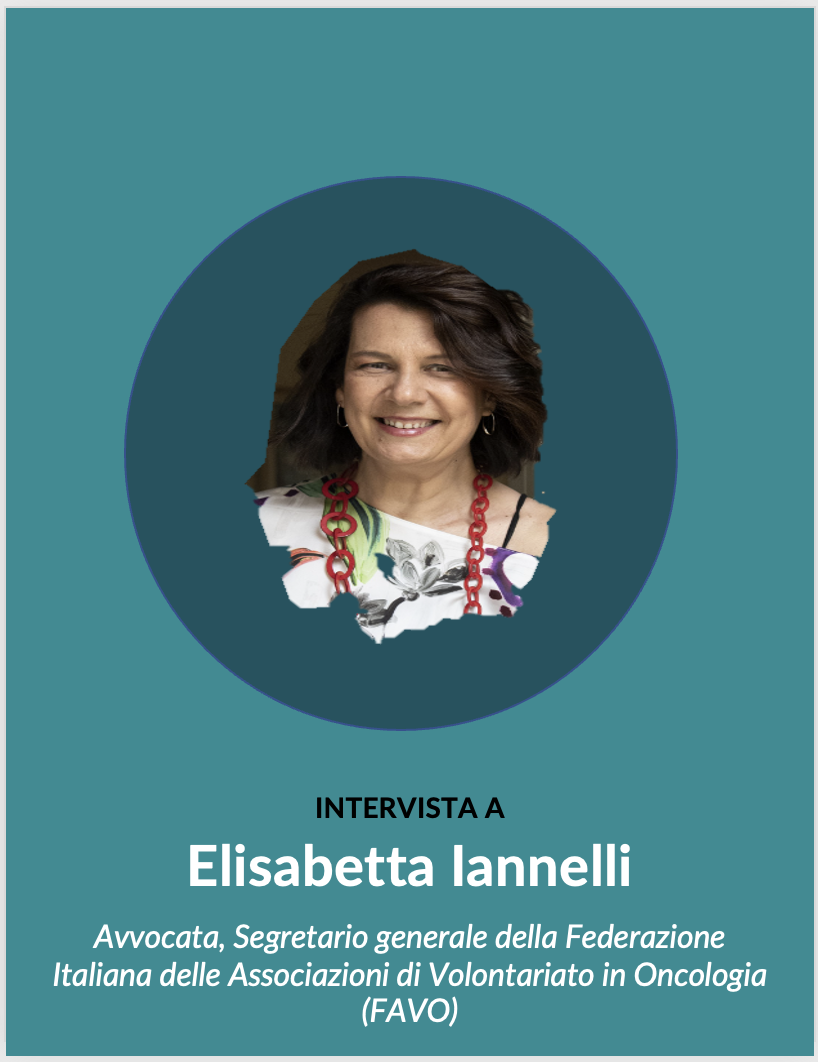La nascita, e le prime 48 ore successive: “fanno la differenza” sostengono gli esperti, ma come e con quale contributo degli infermieri?
Ne abbiamo parlato con i colleghi della Commissione Nazionale d’Albo Infermieri Pediatrici.
In molte culture del mondo, la nascita è un tempo sospeso: un tempo lento, fatto di silenzi, contatto, vicinanza. Un tempo per riprendersi e per conoscersi. E nel nostro contesto?
Nel nostro contesto, spesso, le prime 48 ore in ospedale rischiano di essere un tempo veloce, frammentato. Eppure è proprio lì, in quel breve spazio, che si possono gettare le basi per un allattamento sereno e duraturo. È proprio in questa finestra ristretta che si gioca una parte fondamentale della sostenibilità dell’allattamento.
Sostenere l’allattamento significa sostenere la coppia genitoriale. Le professioni infermieristiche quali responsabilità hanno?
Le responsabilità dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico in questo contesto sono molto più che educative: competenza, empatia, sostegno concreto. Non basta fornire informazioni; serve presenza costante e supporto pratico, in sinergia con le altre professionalità che si occupano della madre e del bambino (ostetrica, ginecologo, pediatra):
- Assistere ed accompagnare la coppia genitoriale nel prendersi cura del neonato, all’interno della stessa stanza di degenza
- Monitorare e valutare lo stato emotivo e fisico della donna dopo il parto, anche in considerazione della prevenzione e individuazione precoce di possibile sintomatologia depressiva.
- Monitorare e valutare lo stato clinico del neonato, anche per identificare eventuale sintomatologia patologica e prevenire il decadimento clinico del neonato.
-
Osservare, valutare, aiutare se necessario e registrare nella documentazione clinica posizionamento e attacco al seno, e l’andamento delle prime poppate (Passo 5 della BFHI).
- Promuovere un contatto continuo madre-neonato, anche durante la notte, ma con l’adeguato supporto, senza lasciare la madre sola nell’accudimento del suo piccolo (Passo 7 della BFHI)
- Promuovere la collaborazione interprofessionale nel sostegno alla coppia genitoriale e al neonato.
Le pratiche raccomandate da OMS e UNICEF (Passi 4 e 7 della BFHI), come il contatto pelle a pelle (skin-to-skin) subito dopo la nascita e il rooming-in, funzionano solo se la madre è sostenuta.
Il rooming-in, in particolare, non può diventare una delega totale alla madre, ma deve essere accompagnato da un’assistenza vigile e attenta.
I falsi miti però non mancano, l’antidoto: il sapere infermieristico…
Alcune credenze ancora radicate possono ostacolare un avvio efficace dell’allattamento. Le Professioni Infermieristiche hanno un ruolo chiave nel contrastare queste “fake science”:
-
-
“Si allatta ogni 3 ore per 10 minuti per seno”, è una regola obsoleta che non rispetta la fisiologia dell’allattamento. E’ altresì importante aiutare le madri nel riconoscere e rispondere ai segnali iniziali di fame del/della bambino/a e orientare un allattamento “a domanda”, ma anche “offerta”, specie per i primi tempi e con i neonati più piccoli o meno attivi (Passo n. 8 della BFHI).
-
“La mamma ha bisogno di riposo, portiamo il neonato al nido”, una frase che sembra protettiva, ma che spesso isola. Separare madre e neonato nei primi giorni può aumentare l’ansia, rallentare la montata lattea, ostacolare il legame. Laddove c’è una madre stanca, ci deve essere un professionista sanitario che accoglie, accompagna, sostiene. Non serve sostituirsi alla madre, ma esserci davvero, senza lasciarla sola.
-
“Se si attacca troppo spesso è perché c’è poco latte, diamo un aggiunta di latte artificiale così dormite meglio entrambi” è una falsa credenza, soprattutto nei primi 40 giorni è assolutamente fisiologico che il neonato si attacchi spesso per calibrare la produzione di latte materno (Passo 6 della BFHI) ed è la base per il proseguimento dell’allattamento esclusivo. Più il bambino poppa, più si svuota il seno e più latte si produce. Inoltre nel latte materno ci sono degli ormoni che promuovono il sonno (melatonina) e l’allattamento al seno favorisce il rilascio di ormoni che promuovono il rilassamento materno (prolattina).
-
Educare dunque, sì, ma soprattutto normalizzare la vicinanza e sostenere emotivamente la madre nei primi momenti, quando la vulnerabilità e le domande sono più forti.
Dall’ospedale al territorio ci vogliono sistemi sostenibili…
Si, la Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno 2025, con il tema “Dare priorità all’allattamento: creare sistemi di sostegno sostenibili”, richiama l’attenzione proprio su questo: costruire reti integrate di supporto tra ospedale e territorio. Le Professioni Infermieristiche, in questo scenario, hanno un ruolo cardine che si esplica già durante il ricovero ospedaliero:
-
Garantire continuità assistenziale anche dopo la dimissione.
-
Collaborare con consultori, pediatri, gruppi di peer support (Passo n. 10 della BFHI).
-
Adattare l’assistenza alle situazioni di vulnerabilità, emotiva, socioeconomica o clinica.
-
Formarsi e aggiornarsi costantemente (Passo n.2 della BFHI) e valutare le proprie competenze (Kit per la valutazione delle competenze).
L’ossitocina funziona sotto stress?
Non dimentichiamo che l’ormone che consente la fuoriuscita del latte, l’ossitocina, è inibito dallo stress. Ridurre la fatica, contenere le paure, creare un ambiente di fiducia e prossimità sono veri e propri interventi assistenziali. Non solo attenzioni “umane”, ma atti professionali, misurabili, replicabili (Articolo 4 Codice Deontologico FNOPI).
Quali sono gli ostacoli da affrontare e quale è il lato meno visibile della promozione allattamento?
Promuovere l’allattamento è un’azione potente, ma tutt’altro che semplice. Nella realtà quotidiana dei reparti e dei servizi, ci si scontra con diverse sfide che mettono alla prova la capacità di offrire un supporto efficace e continuativo alle madri.
Chi lavora ogni giorno nei reparti lo sa bene: mancano le mani, mancano i minuti, a volte manca persino lo spazio per fermarsi un attimo, per ascoltare e osservare. Ma proprio in quei minuti rubati (per aiutare un attacco al seno, ascoltare una paura, sostenere uno sguardo) può nascere un allattamento che durerà mesi.
Per questo servono investimenti, ma anche riconoscimento: perché il tempo assistenziale è tempo di cura.
A questo si aggiunge la pressione commerciale legata ai sostituti del latte materno. Il marketing aggressivo di biberon, tettarelle e formule può creare confusione, minando la fiducia delle madri nell’allattamento naturale (Passo n. 9 della BFHI). È quindi essenziale che il personale infermieristico conosca e faccia rispettare il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno.
Ci sono poi barriere culturali, linguistiche e socioeconomiche: non tutte le madri partono dalle stesse condizioni. Alcune faticano a comprendere le informazioni ricevute, altre non hanno accesso a servizi o supporto familiare, altre ancora sono influenzate da convinzioni che rendono difficile l’avvio dell’allattamento.
Un altro ostacolo frequente è la separazione madre-bambino per motivi clinici o organizzativi. Quando il contatto precoce e il rooming-in non sono garantiti, diventa più complesso stabilire un buon avvio dell’allattamento.
Anche il passaggio dall’ospedale al territorio può essere critico: il supporto nel puerperio spesso risulta frammentato, senza una vera continuità assistenziale tra chi ha seguito la madre in ospedale e chi la incontra dopo la dimissione.
Infine, c’è un aspetto ancora poco considerato: la sostenibilità ambientale. L’allattamento è una pratica intrinsecamente ecologica, ma a volte gli ambienti ospedalieri sono pieni di materiali monouso, plastica, confezioni usa e getta. Mancano spazi adeguati per raccogliere il latte o allattare in tranquillità, e non sempre si riflette sull’impatto ambientale delle forniture utilizzate.
Cosa possono fare le professioni infermieristiche per sostenere concretamente l’allattamento?
In questo contesto complesso, il ruolo delle Professioni Infermieristiche è più che mai centrale. Ecco alcune azioni concrete che possono rendere la promozione dell’allattamento un impegno sostenibile, efficace e continuativo:
-
Applicare protocolli basati sulle evidenze, come i “10 passi per un allattamento efficace” promossi dall’iniziativa Baby Friendly. Attacco precoce, rooming-in e niente sostituti non necessari sono fondamenta cliniche, non opzioni.
-
Investire nella formazione continua: conoscere le tecniche, saper affrontare le complicanze, offrire counseling mirato. La competenza si costruisce e si aggiorna, anche attraverso strumenti semplici come checklist e schede di valutazione.
-
Costruire una rete tra ospedale e territorio che garantisca continuità. Visite domiciliari, gruppi di peer support, consultori familiari: l’allattamento ha bisogno di una rete tempestiva, che funzioni.
-
Prestare attenzione all’equità: ogni madre è diversa. Bisogna intercettare i bisogni, adattare la comunicazione, facilitare l’accesso ai servizi per chi è più fragile.
-
Coinvolgere la famiglia, non solo la madre. Il partner, i nonni, le figure di riferimento possono diventare una risorsa preziosa di sostegno quotidiano.
-
Promuovere politiche ospedaliere sostenibili, sia dal punto di vista lavorativo (spazi per allattare, turni compatibili con la cura) sia ambientale (materiali riutilizzabili, riduzione degli sprechi, scelte consapevoli nell’approvvigionamento).
-
Monitorare e valutare gli esiti: raccogliere dati sui tassi di allattamento, ascoltare le madri, misurare l’efficacia degli interventi (Passo n. 1 della BFHI). Solo così è possibile migliorare davvero.
Fare advocacy, partecipando attivamente allo sviluppo di un protocollo aziendale (passo n. 1 della BFHI), politiche locali e regionali che riconoscano l’allattamento come una priorità di salute pubblica e un diritto per ogni madre e neonato.
L’allattamento è uno dei determinanti di salute?
Si, l’allattamento, uno dei principali determinanti di salute, è molto più che nutrizione: è salute pubblica, è equità, è relazione. Ma perché tutto questo accada, serve una presenza concreta, preparata, empatica, che possono offrire le Professioni Infermieristiche. Le prime 48 ore sono una finestra preziosa — e noi ci siamo, ogni giorno, per aprirla insieme alle madri. Perché allattare non è solo nutrire: è costruire salute, relazioni, equità.E sostenere tutto questo, fin dalle prime ore, è parte essenziale del nostro lavoro.
Per approfondire
- OMS/UNICEF: “Ten Steps to Successful Breastfeeding” (Baby‑Friendly Hospital Initiative) (https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/insieme-per-allattamento/).
- Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno (https://www.epicentro.iss.it/allattamento/pdf/codice.pdf).
- Linee di indirizzo nazionali sull’allattamento al seno (https://www.salute.gov.it/new/it/tema/allattamento/latte-materno-istruzioni-luso/)
- Italianer MF, Naninck EFG, Roelants JA, van der Horst GTJ, Reiss IKM, Goudoever JBV, Joosten KFM, Chaves I, Vermeulen MJ. Circadian Variation in Human Milk Composition, a Systematic Review. Nutrients. 2020 Aug 4;12(8):2328. doi: 10.3390/nu12082328. PMID: 32759654; PMCID: PMC7468880.
- Modak A, Ronghe V, Gomase KP. The Psychological Benefits of Breastfeeding: Fostering Maternal Well-Being and Child Development. 2023 Oct 9;15(10):e46730. doi: 10.7759/cureus.46730. PMID: 38021634; PMCID: PMC10631302.
5 ottobre 2025