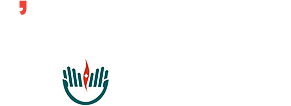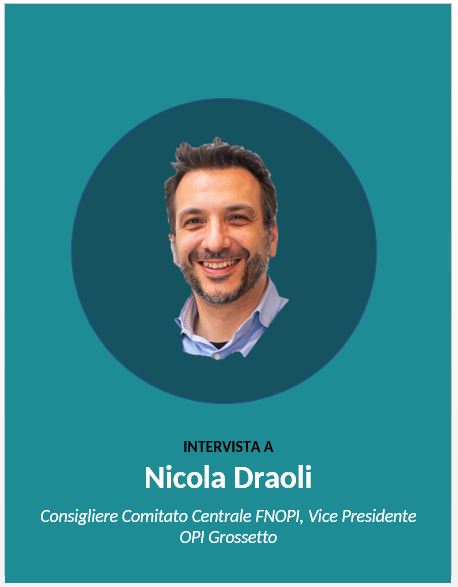Paziente, un termine desueto, oggi particolarmente fuorviante. In passato ha dato forma al rapporto tra chi somministra le cure e che le riceve ma che in questo tempo non è più rispondente al concetto di cura e alla relazione tra curante e curato.
Un termine quindi scorretto non solo linguisticamente ma anche culturalmente, abbandonato dai professionisti ma ancora largamente usato in molti ambiti e circostanze. Un termine che ricorre ancora troppo spesso e che non ci piace: ne abbiamo voluto parlare con il Professor Sandro Spinsanti bioeticista.
Professore, cadrà mai in disuso il termine paziente?
Un giorno o l’altro succederà: l’interdetto del politicamente scorretto paralizzerà la disinvoltura con cui abbiamo fatto ricorso al termine paziente per designare chi si sottopone a una cura sanitaria. Soprattutto la diade così familiare “medico-paziente”, che ha dato forma al rapporto tra chi eroga le cure e chi le riceve, dovrà essere rivista. Se l’assumiamo in funzione di specchietto retrovisore che ci permette di vedere ciò che storicamente si trova alle nostre spalle, ci rendiamo conto che molti aspetti culturalmente dati per scontati in passato non hanno più diritto di cittadinanza ai nostri giorni. A cominciare dalla radicale asimmetria di potere tra i due protagonisti della relazione.
Parlare di paziente non evocava solo il “pathos” che colpisce chi è malato, ma anche una posizione subordinata a colui che ha le competenze per tirarlo fuori da quella condizione, grazie al processo terapeutico. In maniera incisiva, anche se brutale, ha formulato quel rapporto un medico del Seicento, Rodrigo de Castro: “Il medico governa il corpo, come il sovrano governa lo stato e Dio governa il mondo” (Medicus politicus).
Paziente, una parola che evoca malessere…
Un potere assoluto, di cui la docile passività del paziente è la sigla decisiva. “Il paziente comincia a guarire quando obbedisce al medico”: è ancora una sintesi di un medico spagnolo, Gregorio Marañón. L’asimmetria di potere si è col tempo un po’ ammorbidita, senza però essere stata rimessa in discussione fino alla recente rivoluzione promossa dal movimento della bioetica.
È inevitabile che questa eredità storica gravi sulla parola paziente, così da evocare inevitabilmente la posizione one down, rispetto al terapeuta cui spetta quella one up. Di qui il malessere che la parola stessa veicola.
La collocazione che possiamo chiamare “patica” è stata inoltre validata da altri aspetti culturali. Tra questi il dolorismo di stampo religioso. Soprattutto nell’ambito del cattolicesimo è stata messa molta enfasi sul valore redentivo di quanto la malattia induce a soffrire, fino a ipotizzare la figura del “volontario della sofferenza”, ovvero colui che fa del soffrire stesso una specie di singolare vocazione.
Anche se modelli così estremi restano eccezionali, tuttavia l’equivalenza tra lo stato di paziente e la virtù della pazienza è linguisticamente e socialmente diffusa. Il sostantivo paziente trasloca così nell’aggettivo che caratterizza colui che ha nel sopportare pazientemente un destino segnato. Anche al di fuori dei percorsi religiosi, il termine paziente nella nostra società evoca una cura nutrita di ideali filantropico- assistenziali, piuttosto che un intreccio di diritti/doveri che fa corpo con la cittadinanza.
Modificare queste associazioni è ormai un inevitabile bisogno…
Il bisogno di modificare queste associazioni è già emerso. Sia i medici che gli infermieri nelle loro rispettive revisioni del Codice deontologico avvenute dopo Ia svolta del secolo hanno dimostrato una sensibilità tradotta nell’evitare, il più possibile, il termine fuorviante, ricorrendo a sinonimi, dei quali il più inclusivo è “persona malata”; e ovviamente “cittadino”. Per questa operazione è sufficiente un tratto di penna.
Modificare l’atteggiamento sottostante richiede invece un intervento culturale molto impegnativo. Si tratta di entrare nel cuore stesso dell’etica della cura. Il binomio “medico-paziente” va rimesso in discussione in tutt’e due i versanti. Perché alla figura dominante del medico – la “dominanza medica” ha ricevuto il nome da un saggio che ha fatto epoca del sociologo americano Eliot Freidson – va sostituita la complessità dell’équipe curante, costituita da professionisti con competenze diverse e integrate. I quali hanno tutti bisogno di essere attivamente coinvolti nella relazione, soprattutto nello scenario della cronicità e delle cure riferite all’ultimo tratto di strada. La gerarchia piramidale non può essere il modello funzionale a questa nuova modalità di rapporto.
Una modifica non solo linguistica dunque…
E naturalmente va modificato – culturalmente, prima ancora che linguisticamente – il ruolo tradizionalmente attribuito al paziente. Si tratta di andare ben oltre la posizione che trasforma il paziente in “esigente” (Ivan Cavicchi).
Anzi, questa può diventare una trappola insidiosa, se induce a presumere una competenza fasulla – magari acquisita orecchiando informazioni su internet – e ad arrogarsi il diritto di assumere a propria volta la posizione one up, chiedendo o esigendo prestazioni.
Il malato empowered è ben altra cosa. Per accedere a questo stato è necessario un impegno sia sul piano intellettuale che etico. L’informazione va acquisita in un processo graduale, che presuppone la competenza comunicativa da parte del terapeuta e la disponibilità a farsi coinvolgere nelle decisioni da parte della persona in cura. Il tutto in un contesto che richiede una nuova forma di fiducia, nutrita di reciprocità (“Io mi fido di te perché tu ti fidi di me”). Un rapporto culturalmente inedito. Che non verrà garantito da nessuna modulistica di cosiddetto consenso informato, ma sarà il risultato di un duro lavoro da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel rapporto di cura.
Marina Vanzetta
22 luglio 2021