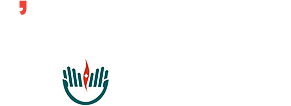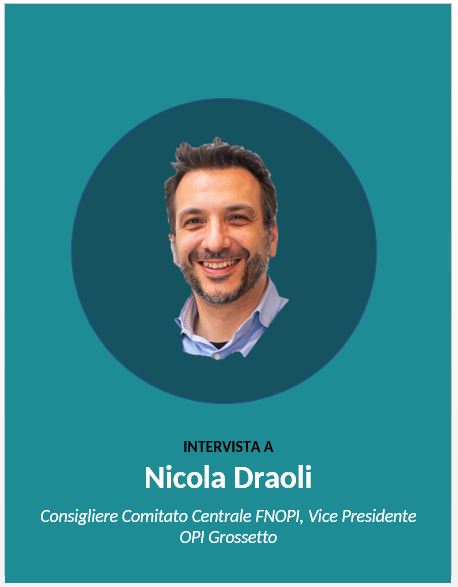Molte e dolorose sono state le scelte assunte in questo periodo pandemico sia nel corso della prima ondata che attualmente. Ogni scelta ancorché indispensabile ha e ha avuto delle ricadute mai indolori e con effetti nel tempo e sul tempo.
Ed è proprio una scelta dolorosa quella che ha fatto Cinzia Botter – Responsabile dei servizi socio-sanitari semiresidenziali e domiciliari, centro diurno, assistenza domiciliare integrata e cure palliative di Osio Sotto – Bergamo a marzo 2020: ha chiuso il centro diurno. Da un giorno all’altro le certezze di incontro, dialogo, scambio, attività, condivisione che riempivano e scandivano le giornate delle persone che lo frequentavano quotidianamente, sono venute meno come è venuta meno la “tranquillità e la serenità” dei familiari rispetto al “benessere” che quella frequentazione garantiva ai loro cari.
Cinzia, perché questa scelta, quanto ti è costata e cosa ha significato per le persone che il centro accoglieva e per i loro familiari?
La scelta fu dettata dalla necessità di mettere in sicurezza i nostri anziani, i nostri operatori e le famiglie. Una scelta difficile, sofferta, ponderata e soprattutto voluta. Passai al telefono tutto il weekend di quel famigerato 7 marzo 2020 e lo ricordo come il tempo più lungo mai vissuto. Un tempo che mi sento di definire contraddittorio per le tante e confuse informazioni che arrivavano da tutte le parti: governo, istituzioni locali, maestranze sanitarie.
Chiamai in prima battuta la mia collega Marianna (Direttrice sanitaria del nostro Presidio Socio Sanitario) e valutai con lei i pro e i contro di questa scelta, tanti erano i contro e zero le obiezioni a favore. Successivamente chiamai il mio Amministratore delegato e condivisi con lui quanto con Marianna avevamo definito e deciso. Ero consapevole che mi assumevo tutte le responsabilità della scelta, della decisione, ma sapevo anche che non ero sola, ero supportata dal resto della direzione aziendale, ma avevo quella strana sensazione che il cammino intrapreso era un cammino difficile, soprattutto per le famiglie che si ritrovavano ad accudire da sole i loro familiari, i loro e nostri anziani.
Il 9 marzo (era un lunedì) arrivai al lavoro percorrendo la tangenziale Est di Milano e l’autostrada in direzione Bergamo con la testa e il cuore pesante, sapevo che dovevo dare la notizia all’equipe assistenziale del Centro Diurno e che dovevamo mettere in campo una chiusura del servizio in tempo zero e senza nessuna ipotesi di riapertura a breve. Mi ricordo come fosse adesso gli sguardi dei colleghi, l’incertezza e anche la delusione del doversi arrendere a qualcosa di più grande di noi. Qualcosa di invisibile che ci imponeva una ritirata in fretta e furia senza lasciare nessuno indietro, senza ostaggi e senza corpi sul campo.
Organizzammo tutto alla perfezione, cercando il più possibile di non stravolgere la routine della giornata dei nostri anziani, questo glielo dovevamo, fu quindi l’educatrice Rossella che attraverso il gioco e il racconto li mise al corrente di quanto stava accadendo e di quello che sarebbe successo da lì all’indomani. Ci dividemmo le chiamate da fare alle famiglie, ma prima di contattarle, definimmo un testo univoco affinché tutti dessero le stesse corrette informazioni senza creare panico o farli sentire soli. Ancora però non sapevamo come avremmo potuto non farli sentire soli.
Ognuno di noi ha la possibilità di fare sempre una o più scelte nella vita sia personale che professionale, e io decisi di fare una scelta professionale forte e importante senza attendere nessuna comunicazione ufficiale dalla nostra ATS né tanto meno da Regione Lombardia, comunicazione che per altro non arrivò mai se non una presa visione della PEC con notizia di chiusura che inviai nel pomeriggio quando il sipario si calò sul nostro servizio.
Sant’Agostino diceva: “Che cosa è il tempo? Se nessuno me lo chiede lo so, se cerco di spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so.”
Questa affermazione è stato il punto di partenza dal quale ci siamo incamminati nel lontano marzo 2020, che poi sembra ieri…, per poter cercare di dare forma a quel sentire di quel lontano tempo compresso e percettibilmente vicino ai nostri sensi. Quel lontano mese di marzo in cui tutto venne sospeso, per alcuni versi dimenticato e che per noi è coinciso con la chiusura del nostro Centro Diurno Integrato.
Abbiamo dovuto prendere una decisione, forte, dura, non voluta ma necessaria, abbiamo dovuto mettere in intervallo una intera generazione di uomini e donne con il solo obiettivo di tutelarli, preservarli da qualcosa di inizialmente inspiegabile. L’abbiamo fatto, li abbiamo allontanati, li abbiamo “ridati” alle proprie famiglie senza calcolare la fatica che “in-consapevolmente” facevamo arrivare dritta come un treno sulle loro spalle.
Potevate chiudere e basta. A sostenere la scelta, un motivo importante, la tutela delle persone del centro diurno ma anche dei loro familiari. Non lo avete fatto, avete cercato un’alternativa…
Sì abbiamo voluto cercare un’alternativa alla chiusura, a quel che tutti noi sentivamo e vivevamo come terribile sentimento di abbandono, ci sentivamo tutti in colpa e io per prima. Ma sono una donna fortunata, sono una professionista molto fortunata, perché ho un gruppo di colleghi (infermiera, educatrice, fisioterapista, operatori di supporto ed assistente sociale) che non si sono arresi, che hanno studiato, pensato, ideato e realizzato un progetto che siamo riusciti a mettere in pratica dopo poche settimane dalla chiusura, abbiamo trovato il sistema di tenerci tutti collegati ospiti, famiglie e operatori.
Per poterlo ridisegnare, questo nostro Centro Diurno, abbiamo avuto bisogno di un tempo sospeso, di un tempo fuori tempo, fuori dalle pratiche del quotidiano, da tutto ciò che si gioca nella dimensione dell’utile e del necessario, abbiamo avuto bisogno di scrivere pagine di sentimento che rappresentano il sentire del Centro Diurno sia dal punto di vista degli operatori, dei familiari che degli utenti.
Infiniti e mai finiti sono stati i contatti telefonici con le famiglie effettuati in quei mesi di sospensione dal reale, dove ogni umana emozione e impulso venivano liberati, urlati, a volte lanciati addosso a tutti noi che in qualche modo volevamo portar supporto, accudimento, vicinanza.
Quando tutto cominciò non eravamo ancora consapevoli che le nostre azioni di cura, verso i nostri anziani, si sarebbero trasformate in nuove pratiche di cura e che avremmo dovuto inventare un metodo rivoluzionario, un nuovo modo di agire la cura, che si sarebbe costruita su nuove esperienze di stare con i nostri utenti e le loro famiglie. Non sapevamo ancora come e cosa avremmo costruito, quale nuova routine, quale e quanta nuova cura della quotidianità, con tutti i suoi riferimenti rassicuranti.
Non sapevamo ancora come avremmo garantito la continuità delle nostre presenze in un contesto che imponeva distanza, una nuova condizione di ascolto e rispetto, di attenzione ai diversi ritmi nella e della giornata, una nuova dimensione di affetto che si sviluppava nella frequentazione assidua, nella condivisione di emozioni e sentimenti che nascevano nella relazione.
Eravamo in-coscienti che ci sarebbe stata tolta la routine che ognuno di noi aveva, fatta di regole, di procedure, di convenzioni, di abitudini e di strategie attorno alle quali il nostro Centro Diurno era stato costruito.
Era un tempo in cui non potevamo oltrepassare i limiti, dovevamo rispettarli, accettare il senso del limite dettato dal dolore della chiusura del servizio, che a ritroso si stava delineando giorno dopo giorno.
A piccoli passi… momento dopo momento…emozione dopo emozione, curando un passo dopo l’altro, chiamavamo i nostri utenti e i loro caregivers, ascoltavamo i loro bisogni, cercando di accogliere anche ciò che le parole non sempre riuscivano a confidare, accompagnando, supportando e sostenendo ognuno di loro.
In questo modo stavamo delineando una nuova strada di cura in una relazione di distanza fisica ma non di sentimento, dove la distanza non era assenza di relazione, ma la cornice di testo razionale che ci avrebbe accolto in una storia comune.
Ogni giorno nel contatto telefonico con i nostri utenti e le loro famiglie stava prendendo forma l’intenzionalità di realizzare un progetto per entrare nelle case non fisicamente ma virtualmente. Entrare nelle vite dei nostri anziani e delle loro famiglie, perché esserci virtualmente era importante quanto l’accudimento in presenza. Stavamo cercando di creare un’alleanza, stavamo cercando di non farli sentire soli. Stavamo cercando di non obliare, e forse quel bisogno inizialmente era più nostro per il terribile senso di colpa che ci aveva pervaso.
Avevamo un sogno, un obiettivo che era far vivere frammenti della loro quotidianità al Centro Diurno direttamente nella loro casa, coinvolgendo i figli, le mogli, i mariti e i nipoti che avrebbero agito una nuova cura fatta di strategie e non solo presenza.
Il dato certo era che questa tecnologia fatta di video, suoni e voci rimbalzati via web, non incideva sull’anziano, non la percepivano come una relazione distorta e veicolata da uno strumento non “umano”. Avevano la percezione e la consapevolezza dell’esserci qui e ora.
Le difficoltà non sono mancate visto il periodo, ma avete saputo costruire un’alleanza con i familiari. Come ci siete riusciti?
La storia del nostro servizio è caratterizzata da trasparenza e coinvolgimento diretto con le nostre famiglie. I servizi territoriali siano essi residenziali, domiciliari o semiresidenziali come il nostro, non possono esimersi dal non coinvolgere in modo attivo e proattivo la famiglia dell’anziano, dell’utente, dell’ospite, della persona. Non si può lavorare e prendersi cura di una persona se non si instaura un patto di alleanza con la famiglia, se non stabilisco un dialogo bidirezionale, se non si ricerca supporto, aiuto e consiglio alla famiglia. Non c’è cura senza la famiglia e senza il link pregno di emozioni che ogni professionista, ogni equipe instaura con la persona assistita e il suo enturage familiare.
Noi siamo partiti da questo, dalla relazione di fiducia, dal link emozionale consolidato nel tempo e dal rispetto.
Coltiviamo molto questi aspetti, per noi sono vincenti.
Gli anziani e le loro famiglie rispondevano con l’infiammo che li ha sempre contraddistinti, con l’entusiasmo della prima volta, con la gioia del vederci e del sentirci, con la meraviglia dell’essenza. Non percepivano alcuna distanza.
La famiglia non nego che comunque era affaticata, per mille comprensibili motivi dettati dalla situazione che tutta Italia stava vivendo. Le famiglie ci inoltravano video e fotografie quotidianamente, e si percepiva chiaramente il bisogno di tenerci tutti collegati, di sentirsi collegati. Eravamo tutti lì, loro e noi, noi con loro come se il distacco non fosse mai avvenuto. La partecipazione era entusiasmante, era attiva, partecipata e ambita ogni giorno.
Ogni giorno attività diverse per non incorrere nella monotonia che a volte avvolgeva tutti noi, la sensazione evidente era che tutti stavamo lì in quel luogo abbandonato in fretta e furia il 9 marzo 2020 e che per noi tutti era Casa.
Dopo il primo mese ci siamo spinti oltre e abbiamo proposto la “vicinanza protetta”, la visita di operatori che entrando in casa potessero abbattere ancora di più la distanza forzata, ed ecco che educatore, fisioterapista, operatori di supporto, infermieri si recavano al domicilio per accorciare la distanza. Le visite che facevamo ci permisero di toccare con mano se ci fossero altri bisogni che il video non esaltava, non riconosceva, e in alcuni casi intercettavamo bisogni sanitari che nascondevano anche dei bisogni sociali. L’evidenza di questi bisogni veniva evidenziata anche dall’ascolto, dalla narrazione, dalla sfumatura della voce del famigliare e dallo sguardo mascherato. Emergevano bisogni di vita, ed ecco allora la messa in opera della costruzione di rete territoriale con i tanti servizi presenti e a volte poco conosciuti, ma soprattutto non raggiungibili causa lookdown. Nei casi di maggiore fragilità e isolamento siamo intervenuti creando LA RETE con gli assistenti sociali, con le UTES (unità territoriale emergenza sociale istituita dal consiglio dei sindaci della provincia di Bergamo proprio per sopperire alla grave carenza ed emarginazione sociale data dalla pandemia) e i medici di medicina generale.
Non trascorrevano giorni in cui non ci fossero scambi di emozioni. Le pratiche di cura quotidiana degli operatori avevano più che mai il compito e la responsabilità di aiutare i caregivers e gli anziani a rintracciare competenze che rischiavano di rimanere non viste. Competenze che rischiavano di diventare indisponibili in una nuova esperienza critica, che sovvertiva più che mai le posizioni familiari, introduceva ruoli inediti, assegnava nuove misure agli spazi parentali e ai ritmi quotidiani, che comportava una ristrutturazione del menage familiare che provocava fatica fisica e psicologica, dove la regola di base impartita in quel periodo era proteggere sé e gli altri e dove per gli anziani era difficile a volte da comprendere. Più che mai si insinuavano dubbi e incertezze. Il processo di sostegno degli operatori del servizio richiedeva non solo di operare in funzione degli anziani, ma della sua famiglia nella sua globalità, sapendo cogliere con discrezione e delicatezza le fatiche di una complessità sociale che si riversava nella storia particolare di una famiglia che si stava prendendo cura dell’anziano. A partire dalla capacità di intuire e accogliere ciò che non sempre le parole riescono a confidare, gli operatori avevano la responsabilità di affiancare gli anziani e i caregivers nell’esercizio di un ruolo da sperimentare quotidianamente e amplificato dallo svolgere ogni tipo di attività rimanendo in casa.
Col venire delle giornate i vissuti raccontati attraverso la cornetta di un telefono o ripresi da una videocamera sembravano sempre più condivisi in presenza; si stava creando un modo dell’esserci e dell’essere insieme, dove l’incedere di ognuno avevano una ri-sonanza. E quando prima di dormire ci si fermava a riflettere su quanto accaduto nella giornata si apriva nella stanchezza e nella fatica, lo stupore di consolidare sempre più un legame di fiducia con l’anziano e la sua famiglia. Stavamo imparando un nuovo modo di vedere e di ascoltare, rinunciando all’ovvietà delle cose, ci stavamo allenando a coltivare lo sguardo e l’udito, a recepire piccole sfumature che cercavano di rispondere ai bisogni.
Dopo molti mesi, a ottobre avete riaperto il centro diurno. Come è cambiata la “normalità” oggi rispetto a quella di allora, prima della chiusura?
Cosi passavano i giorni che poi divennero mesi, accompagnati dalla speranza di riaprire il nostro servizio ma senza la reale consapevolezza di come sarebbe cambiato questo vivere il centro diurno.
Ci trovammo a progettare un servizio nuovo, tessuto di relazioni cucite da dolori dettati da perdite, attese, fatiche, paure, dubbi.
Ci trovammo a riprogettare e ricostruire alleanze, corresponsabilità di una comunità che voleva continuare a vivere insieme ma con il rispetto delle norme e delle distanze per tutelare la vita di ogni anziano e operatore. Ad ottobre dopo una serie di riflessioni, condivisioni, progettazioni, giunse finalmente quell’agognato momento della riapertura, della ri-accoglienza dei nostri anziani.
Fummo “costretti” a mettere da parte l’abitudine di quello che per noi era normalità di accudimento, di cura, di relazione. Come sempre dovevamo porgerci con creatività e leggerezza di sguardo verso la costruzione del nuovo, dove il rispetto delle distanze non doveva imporre confini relazionali di socializzazione, ma dovevamo accompagnare noi e i nostri ospiti a comunicare con gli occhi, con nuovi gesti per stabilire un con-tatto senza contatto, dove l’espressione visiva delle emozioni e della voce arrivasse oltre le distanze. Potevamo finalmente accogliere la corporeità dei nostri anziani, aver cura del loro quotidiano in presenza, darci tempo e strumenti per osservarlo, per ripensarlo, per raccontarlo, renderlo narrabile, impregnare di tenerezza la relazione con gli anziani, ossia farci calco dei vissuti di ognuno di loro, trovando in quello scrigno di vita comunitaria gli alfabeti cognitivi, i codici affettivi, i frammenti di racconti da assumere come perno della comunicazione e della sintonia relazionale che si sviluppa in presenza.
Potevamo finalmente entrare nelle sfumature di un volto, di un gesto per mettere a disposizione i nostri sensi. Una signora dopo pochi giorni di nuova presenza al centro diurno pronunciò: “Avevo paura di non rivedervi più, avevo paura di rimanere così muta e sorda”. Queste parole ridonderanno per sempre nella nostra mente e saranno sempre il motore per convincerci che il benessere dei nostri anziani è dato dalla frequentazione in presenza perché il loro bisogno più grande è lo stare insieme, è sentire la voce dell’amore, quella voce che regola il comportamento di ogni persona sulla base di come si comunica, in virtù di quello che si coglie dai comportamenti, dai silenzi, dalle posture, dai toni di voce. Quella voce che non si trasmette con il linguaggio, ma quella che ha canali comunicativi più immediati, la comunicazione non verbale, che non si interrompe mai, non può essere sospesa e che è comprensibile aldilà di ogni demenza o patologia. Proprio su queste riflessioni, l’unica certezza che abbiamo in questo momento sospeso è che l’in-certo ci ha portato a riflettere che ognuno di noi, e maggiormente i soggetti più fragili come gli anziani, necessitiamo di trovare qualcuno che sia indubitabile e quotidianamente dentro di noi e fra noi. Le persone con demenza nel loro smarrimento, distaccamento e distanza con il mondo e dal mondo richiedono quotidianamente la vicinanza per poter stare in relazione, ma non potendo sempre utilizzare un codice universale di linguaggio si ritrovano ad utilizzare, con consapevolezza o meno, nuovi modi per relazionare.
Noi operatori della cura allenandoci nell’osservarli e nello stare con loro, dovremmo forse imparare a con-vivere dentro questo momento di distanza e di ricerca di vicinanza per scoprire forse l’essenza della cura alla demenza?
Come la vivono le persone che sono tornate al centro diurno? E i loro familiari?
I nostri anziani capirono da subito che il ritornare a vivere il servizio tutti insieme era per loro vitale. Mi ricordo il primo giorno quando sono arrivati, scaglionati negli orari per evitare l’assembramento, e accompagnati dagli operatori del servizio trasporto o dai propri familiari, che orgogliosamente ci consegnavano l’autocertificazione di assenza sintomi e che effettuavano il triage con naturalezza, come fosse per loro la normalità di questo tempo.
I nostri ospiti sanno perfettamente che questa nuova dimensione è obbligatoria, ma la vivono con leggerezza e responsabilità. Loro sanno che solo facendo così sono potuti tornare a vivere.
Le famiglie, non nego, al principio erano preoccupate temevano la possibilità del contagio. Prima della riapertura incontrammo inizialmente in plenaria e poi separatamente ogni famiglia spiegando cosa sarebbe cambiato, come sarebbe cambiato e quale patto di corresponsabilità andavamo a sottoscrivere insieme. Noi avevamo riprogettato il centro seguendo le ferree norme che Regione Lombardia impose come regole anti contagio e chiedemmo alle famiglie l’ennesima alleanza per far sì che tutto venisse svolto nell’osservanza delle stesse.
Dopo solo pochi giorni di frequenza abbiamo notato la “fioritura emotiva” e la “luce negli occhi” dei nostri ospiti, abbiamo riascoltato le loro voci che giorno dopo giorno sono diventate più sicure, abbiamo sentito le loro risate che sono riemerse in un crescendo di voglia di essere felici.
Le famiglie sono serene, stanno vivendo una nuova normalità, una nuova dimensione in condivisione con noi di cura dell’anziano.
Tutti noi auspichiamo a tornare ciò che eravamo, auspichiamo a tornare a fare progetti di vicinanza anche con tutti gli altri attori del territorio, sappiamo che è solo questione di tempo, noi ci crediamo.
Se potessi tornare indietro faresti la stessa scelta?
Senza ombra di dubbio, non potrei permettermi mai di mettere a rischio nessuno. A volte la difficoltà nel fare una scelta sta anche nella consapevolezza che la responsabilità non è sempre condivisibile. Non credo che a me è andata bene solo perché ho fatto una scelta di protezione, io sono convinta che la scelta che ho fatto con afflizione, non solo è stata compresa dai miei colleghi, ma tutti sapevamo che era l’unica scelta da agire. L’immobilismo è una scelta, io ho scelto di muovermi, i miei colleghi hanno scelto di correre con me la complessità di una opzione che stava nel comprendere come non abbandonare anziani e famiglie. Ma grazie al grande lavoro di squadra ci siamo riusciti.
Marina Vanzetta
25 gennaio 2021