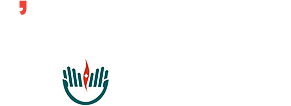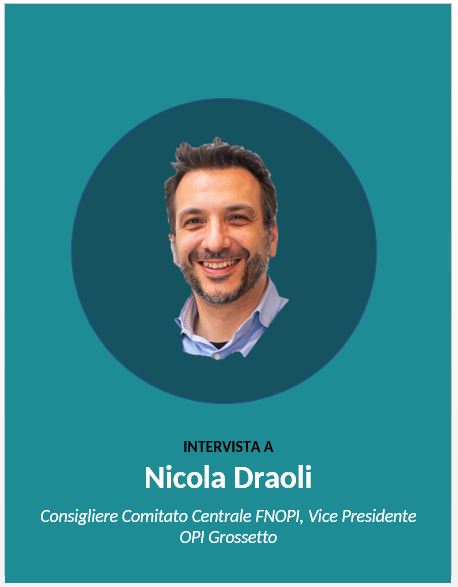La medicina vestita di narrazione, Morire in braccio alle Grazie e La medicina salvata dalla conversazione, una trilogia in cui il filo conduttore è la relazione di cura che per certi versi sembra essere malata.
Abbiamo incontrato l’autore, il Professor Sandro Spinsanti uno dei più noti esperti italiani di bioetica, e li abbiamo brevemente “attraversati” con lui.
Il primo libro La medicina vestita di narrazione è dedicato alla Medicina narrativa e già nelle prime pagine emerge un interrogativo. Prof. Spinsanti lei inizia il capitolo 1 così: Anzitutto disambiguare. Perché?
L’esortazione a disambiguare è suggerita dal fatto che, entrando nel territorio delle Medical Humanities, il rischio di malintesi è dietro l’angolo.
Per esempio, tradurre questa pregnante espressione inglese semplicemente con “umanizzazione” della medicina.
Questo termine è seducente, e di fatto lo sentiamo risuonare spesso. Ma quante volte chi si propone di umanizzare non intende altro che entrare nell’atteggiamento interiore dei professionisti della cura, riducendo l’umanizzazione a un’esortazione a farlo con cuore, attingendo a sentimenti filantropici.
Certo, più gentilezza e bontà d’animo non guastano; ma le Medical Humanities hanno un’ambizione più alta. Vogliono abbinare le scienze umane al sapere che proviene dal versante delle scienze biologiche, creando un nuovo strumento per capire la persona malata, i suoi bisogni, la sua collocazione nel percorso di cura e favorendo la sua partecipazione attiva alla crescita in salute.
L’intervento efficace su un organo malato, garantito dalla migliore medicina scientifica e tecnologica, va integrato con la considerazione delle altre dimensioni del vissuto di cura.
Un altro esempio di ambiguità: come abbinare la qualità morale alla figura del professionista?
Parlare di medici/infermieri buoni è diverso dall’evocare buoni medici/infermieri. Nel primo caso ci riferiamo alle motivazioni con cui praticano la professione e ai sentimenti che li animano; nel secondo, invece, facciamo appello a delle modalità con cui applicano la cura.
Siamo consapevoli che i buoni medici/infermieri dei nostri giorni sono diversi da quelli del passato.
La competenza comunicativa non faceva parte della qualifica di un buon professionista sanitario, mentre ai nostri giorni è imprescindibile.
L’infermiere buono d’animo non è un buon infermiere, se non sa usare le parole giuste per comunicare con il malato.
Il testo è ricco di stimoli alla riflessione, di suggestioni, e di ancore alla realtà che rendono quasi inevitabile questa domanda ma è davvero la narrazione l’unica chiave capace di aprire la porta a una medicina personalizzata?
La narrazione è un concetto ampio: un albero frondoso che ha prodotto diversi rami.
C’è la narrazione letteraria, che ci favorisce una più ampia comprensione dell’esperienza umana. Il romanzo La morte di Ivàn Ill’ic di Tolstòj – per dire – ci fa penetrare nell’animo di chi sta affrontando la fine della vita in un clima di informazioni ingannevoli che circolano in famiglia.
E il film Still Alice ci fa capire come nessun trattato di neurologia che cosa significa precipitare nella demenza di Alzheimer.
Ciò che il medico-scienziato vede al microscopio osservando un tessuto o l’oncologo registrando le reazioni dell’organismo a una cura chemioterapica è importantissimo; ma la persona umana è molto più della somma degli organi e la malattia molto più complessa del deragliamento della filiera genetica. Per questa comprensione abbiamo bisogno di ricorrere a strumenti narrativi e artistici.
Un secondo prodotto della narrazione è il racconto del proprio vissuto di malattia e del percorso di cura.
Narrazioni di questo tipo sono chiamate in inglese “misery report”; in italiano li possiamo qualificare come “racconti del dolore”. Ne sono pieni scaffali interi delle librerie e traboccano dai siti internet.
Oggi chi incontra malattie e perdite nella propria vita si sente autorizzato a condividere il proprio vissuto raccontandolo. E si confronta con altri che hanno attraversato prove analoghe. Il beneficio psicologico, nonché l’ampliamento della propria visuale di esperienza, sono notevoli.
In terzo luogo la medicina narrativa comporta l’acquisizione della capacità comunicative che, come vedevamo, qualifica la buona medicina dei nostri giorni.
Tutto ciò è incluso nell’ideale di una medicina personalizzata.
Il secondo, Morire in braccio alle Grazie è dedicato al tema del fine vita. Nel secondo capitolo intitolato Morire con grazia sottolinea come quando si pensa agli aggettivi da accostare a una morte auspicabile, graziosa non ricorre mai. Perché si dovrebbe parlare di morte graziosa, come può esserlo questo momento della vita?
Mi rendo conto che parlare di una “morte graziosa” suona come una provocazione. Ovviamente qui l’aggettivo va riferito letteralmente alle Grazie, dee della bellezza; in questo senso parlo piuttosto di morire in braccio alle Grazie.
Questo percorso inusuale ha un vantaggio: ci costringe a misurarci con ciò che le persone, diverse le une dalle altre, considerano bello.
Sfuggiamo così all’ambiguità nascosta in certe espressioni riferite alla fine della vita. Per esempio, “morte dignitosa”.
Una qualificazione che può caricarsi di molto paternalismo, nel senso di un giudizio esterno su che cosa è dignitoso per una persona e cosa non lo è.
Le Grazie, in quanto simbolo di bellezza, ci portano nell’ambito dell’estetica, e quindi della soggettività. Ciò che è bello per una persona può non esserlo per un’altra; ciò che troviamo bello in un momento della vita può non piacerci più in un’altra fase dell’esistenza.
Lei accosta il percorso della buona morte a Eufrosine, Aglaia, Talia, saggezza, serenità e pienezza. Che cosa significa morire in braccio a queste tre Grazie?
Le indicazioni che vengono dall’etimologia dei nomi delle Grazie ci permettono di addentraci nel loro territorio.
Possiamo dare così concretezza al “bel morire” che è nelle nostre aspirazioni. Eufrosine ha nel nome la saggezza, ovvero un “bel pensare”.
Siamo agli antipodi dall’affrontare la morte senza pensiero, senza consapevolezza. Soprattutto quando la vita si conclude in un contesto medico, è accompagnata da molte decisioni relative a cosa fare e cosa omettere, quanto puntare accanitamente su interventi curativi o su quelli palliativi.
Un conto è se tutto ciò avviene con la consapevole partecipazione di chi sta morendo, o se le decisioni vengono prese alle sue spalle, anche se chi sceglie lo fa per il suo bene.
Aglaia è sinonimo di serenità.
Sempre più le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) ci garantiscono che potremo essere parte attiva del processo con cui ci avviciniamo all’ultima soglia.
Poter decidere la quantità e soprattutto la qualità della vita al suo epilogo è un elemento fondamentale della cultura personalizzata del morire.
Infine Talia, che contiene nel nome crescita e pienezza.
Ha a che fare con gli anni della vita, ma non solo: un’esistenza incompiuta può essere compatibile con un’alta età, mentre la pienezza è sinonimo di obiettivi raggiunti.
E questa pienezza – questo “Nunc dimittis… in pace”, potremmo dire con un linguaggio religioso – può essere conseguita in qualsiasi momento dell’arco vitale.
Si tratta della crescita spirituale, possibile sia dentro che fuori dalla religione.
Stiamo parlando di utopie o di sogni?
No: semplicemente di modelli di fine vita auspicabili. Introdurli in una pratica medica che sembra avere come obiettivo solo il prolungamento della vita e non anche la sua qualità è una grande sfida e richiede un notevole impegno.
Nel terzo, La Medicina salvata dalla conversazione dedica il primo capitolo alla medicina malata, qual è la sofferenza della medicina Professore?
Sono numerose le patologie che affliggono la medicina, ossia lo strumento che ci siamo creati per riparare i danni che la natura infligge al nostro corpo.
Forse la più vistosa è lo sbilanciamento verso la dimensione scientifico-tecnologica. Una medicina di questo tipo assomiglia di più a una riparazione di meccanismi rotti che a ciò che intendiamo per cura. È la medicina high tech e low touch.
Anche una medicina che non sa comunicare è malata.
Cito solo un esempio: da qualche tempo abbiamo messo l’accento sul fatto che una buona pratica di cura richiede che il malato sia informato e dia il suo consenso, partecipando attivamente ai trattamenti.
Ebbene, nella pratica quotidiana tutto ciò si è ridotto a estorcere al paziente una firma da apporre al modulo del cosiddetto “consenso informato”.
Anche questa è una medicina malata, che ci dovremmo impegnare a guarire.
In che modo la conversazione può salvarla?
Per capire la conversazione a cui facciamo appello partiamo dal suo contrario.
Abbiamo avuto di recente il confronto pre-elettorale tra Trump e Biden negli Stati Uniti.
Ebbene: quella esibizione è il contrario esatto di una conversazione.
Oppure pensiamo a tanti talk show televisivi ai quali ci tocca assistere.
Anche in questi casi prevale l’arroganza, la convinzione di avere ragione mentre chi la pensa diversamente è nel torto, il tentativo di piegare o di distruggere l’altro.
La conversazione richiede il rispetto reciproco dei conversanti.
E anche il tentativo di colmare le asimmetrie informative.
Queste sono molto importanti in ambito medico, malgrado la tendenza crescente dei cittadini del nostro tempo di acquisire sempre più conoscenze.
Non da ultimo la conversazione, anche in ambito clinico, richiede parole oneste.
Questo è l’argomento di un altro libro, che ha fatto seguito alla trilogia a cui ci stiamo riferendo: La cura con parole oneste (Il Pensiero Scientifico, 2019).
Elemento comune in tutti e tre i testi sono i rimandi a opere letterarie e artistiche perché?
Nel mondo di Cura – la dea da cui dipendiamo per tutta la vita, così come è stata evocata dal mitografo latino Igino – ci sono più cose di quelle che conosce la medicina.
Senza svalutare ciò che ci fornisce la scienza, abbinata alla tecnologia, possiamo rivolgere la nostra attenzione a ciò che ci viene offerto dalle Medical Humanities. Scienze umane, letteratura, arte: tutto ciò allarga il nostro sguardo.
Ne abbiamo bisogno tutti: medici, infermieri, altri professionisti della cura, da un lato, cittadini dall’altro.
Ci incontriamo nelle narrazioni e nell’arte per scoprire che la cura è più che una tecnica di riparazione: è la sostanza della vita umana stessa. E oltretutto frequentare questi alti prodotti dell’ingegno umano è estremamente piacevole.
Marina Vanzetta
4 ottobre 2020