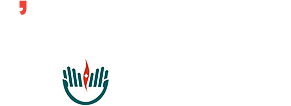Inizierò questo mio racconto partendo dal momento in cui un mio caro collega mi ha chiesto di mettere nero su bianco la mia esperienza nel reparto Covid dell’Ospedale di Cattinara. Mi concedo questa non logicità nel descrivere gli eventi perché in fondo cosa ci è stato di così logico in questi ultimi mesi?
Quando mi venne chiesto di raccontare quelle che sono state le mie sensazioni avendo svolto servizio come infermiera presso il reparto pneumo-Covid ho avuto un attimo di turbamento perché come puoi descrivere a parole quello che la tua mente e il tuo animo percepiscono in alcune situazioni della vita, è cosi complicato che il più delle volte si tende a tener per se quello che si è vissuto senza capire che probabilmente raccontarsi può essere motivo di un lavoro introspettivo che ti aiuta personalmente e che forse può aiutare anche tanti altri.
Dunque la mia esperienza lavorativa presso l’Ospedale di Cattinara non poteva iniziare in uno dei peggior momenti della storia sanitaria italiana divenuta poi una catastrofe mondiale. La chiamata di assunzione tanto attesa dopo mesi di sacrifici arriva in tempi non sospetti dove i primi casi di Covid venivano raccontati al telegiornale con non molta apprensione.
Dopo poche settimane i numeri dei contagiati e di morti aumentava esponenzialmente e iniziò il lockdown. Quel giorno durante il discorso del Presidente del Consiglio ero a tavola ed incredula assistevo all’inizio di un lungo travaglio. Tentai allora di esorcizzare il tutto sperando che tutto si risolvesse in poco tempo prima della mia partenza da Roma a Trieste. Ogni sera prima di coricarmi pensavo: “è un brutto sogno ci risveglieremo tutti”. Invece purtroppo così non è stato, dopo pochi giorni mi ritrovai a partire per Trieste con poche valigie, senza aver salutato nessuno dei miei cari. Tutte le partenze sono tristi ma questa è stata certamente quella che non dimenticherò per via del fatto che sia avvenuto nel bel mezzo di una vera e propria guerra virale.

Venivo infatti assunta il 1 Aprile, il Covid era già un mostro che aveva insediato seppur in maniera diversa le varie regioni italiane. L’ansia e la paura di questo mostro da nessuno conosciuto prima in questa forma ha purtroppo cancellato quel momento di felicità che attendevo da tempo. Non vedevo l’ora di iniziare la mia carriera lavorativa, ma allo stesso tempo mi chiedevo come avrei potuto affrontare il tutto.
Incontrare i colleghi con la mascherina ricordo che è stata forse la prima cosa che mi colpì appena entrai nel mio reparto di appartenenza, ero curiosa di vedere i loro volti e potergli stringere la mano soprattutto. Per fortuna gli occhi si sono sostituiti a tutto ciò e ad essere sinceri ripensandoci oggi forse una cosa che abbiamo tutti imparato da questa esperienza in cui mantenere le distanze era divenuta una questione di sicurezza per la salute di ciascuno di noi è stata proprio guardarsi negli occhi. Tante volte siamo così presi dai gesti della vita quotidiana, così sempre di corsa che ci dimentichiamo dei VERI gesti. E se c’è una cosa che questo periodo mi ha insegnato è proprio questa: fermarsi, attendere.. tempo ne abbiamo e dobbiamo davvero viverlo con genuinità e rispetto per le persone alle quali questo tempo è stato bruscamente tolto senza alcun preavviso da questo virus maledetto.
Questa mia riflessione venne poi maggiormente accentuata quando iniziai a lavorare nel reparto Covid. Inutile raccontare come i DPI utilizzati coprissero tutte le parti del
nostro corpo ad eccetto proprio degli occhi. Li però almeno con i guanti potevamo stringerci la mano pur ripensandoci. Dodicesimo piano della torre medica, come dimenticare il percorso di accesso al reparto e soprattutto come dimenticare i sentimenti contrastanti che ti assalgono ad ogni piano prima di arrivare: ansia, paura, incertezza ma allo stesso tempo tanta determinazione. Io personalmente credo che da ogni cosa che accade nella vita c’è qualcosa da imparare e quindi pensai: “Silvia non ti abbattere e dai il meglio di te per queste persone, per questo lavoro che hai scelto e che nonostante la stanchezza a fine turno ti fa sempre dire non c’è nient altro che farei”.
Il primo momento fu l’ingresso nel reparto, si accedeva ad una zona di vestizione dove sarò onesta non sapevo da che parte iniziare. Ma è questione di pratica quella: vestizione, svestizione, vestizione, svestizione.
Ciò a cui non ti abitui davvero è la tua impotenza di fronte a questo virus che se pensi davvero sia una cosa macroscopicamente invisibile all’occhio umano ti senti quasi fallito in partenza nel vedere i danni che crea a seconda dei casi. E allora torni e ritorni a lavoro, la tuta così coprente e imponente non ti da più fastidio, la mascherina così aderente al volto ti fa comunque respirare, ai segni che lascia non ci fai più caso, la visiera inizi a sopportarla e la stanchezza fisica e mentale vengono meno quando sei “chiuso” li.
Sembra paradossale ma se non avessi avuto difronte i miei colleghi “bardati” come me avrei quasi sempre dimenticato di avere tutto ciò indosso perché quando presti assistenza a questi pazienti viene prima il loro benessere e poi il tuo. Ricordo quasi come fosse ora che cercare di poter fare qualcosa per loro anche solo farli parlare con i loro cari ti rendeva felice perché tutti noi uscivamo di lì comunque ma loro, loro no e chissà come e quando ne sarebbero venuti fuori.
Nell’assistenza infermieristica ti insegnano sin dai primi giorni di università che un vero professionista della salute deve saper fare, far fare ma soprattutto saper essere. Allora pensavo a come fosse possibile in quel caso saper essere se pensiamo al fatto che stabilire un rapporto empatico era davvero complicato dal momento che i nostri DPI in un certo modo lasciavano poco spazio ad una libera espressione del volto e coprissero i sorrisi comunque donati anche nelle situazioni più critiche.
Queste riflessioni ovviamente erano esterne dal reparto, tornata a casa ripensavo a tutto ciò e solo ora mi rendo conto che a pensarci bene siamo stati in grado di ESSERE senza neanche farci caso, perché noi infermieri siamo così; semplicemente siamo e ci doniamo nel corso della nostra giornata lavorativa senza neanche rendercene conto. Il nostro lavoro è si praticità nello svolgimento della pratica ma è essere soprattutto perché chi abbiamo davanti, chiamiamolo pure paziente o cliente, è una PERSONA. In quel reparto dunque noi conoscevamo bene chi i nostri pazienti fossero ma loro di noi non conoscevano nulla se non il nostro nome scritto sulla tuta e mi piace pensare che almeno questo e i nostri occhi incoraggianti possano averli aiutati a lenire la sofferenza e ad avere fiducia nel domani.
Della mia esperienza di due mesi trascorsi nel reparto Covid posso dire semplicemente che a volte dalla situazioni peggiori vengono fuori poi le cose migliori che ognuno di noi ha in se e credo che i colleghi con cui ho avuto l’onore di lavorare potranno solo che confermare che ciascuno di noi si è messo in gioco senza alcuna riserva portando in campo esperienza, professionalità, impegno ma soprattutto dedizione.
La paura di infettarsi e diventare poi un pericolo per i nostri cari e i nostri colleghi ovviamente non si può tralasciare ma credo che di contro abbia sempre prevalso un senso del dovere che ha permesso a tutti noi di non arrenderci di fronte alle situazioni di difficoltà che nelle precedenti settimane abbiamo affrontato.
Quando ci comunicarono la chiusura del reparto io e tutti i miei colleghi non potevamo che essere che sollevati ovviamente e così il vivere in questa bolla lavorativa si è dissolto da un giorno all’altro, la tuta è sparita e finalmente siamo nelle nostre divise felici di muoverci liberamente senza le nostre “mute” ma soprattutto felici perché il numero di malati, critici e non, è diminuito. Questo mi rende felice perché forse questa battaglia non l’abbiamo vinta ma abbiamo lottato in prima linea come del resto facciamo ogni giorno ma forse ora non solo noi ce ne rendiamo conto.
L’accortezza è e deve essere ancora tanta perché purtroppo questo virus non possiamo ancora arginarlo del tutto e dunque nella speranza che si torni presto a qualche mese fa, dove tutto questo solo a pensarci sarebbe sembrato impossibile, dobbiamo tutti ragionare in un’ottica di sicurezza per noi ma soprattutto per i nostri pazienti.
Ora che sono da poco rientrata nel mio reparto tutto questo sembra lontano ma in realtà è solo passato da poco e la ripresa della vita “normale” ci ha forse consentito di mettere questa esperienza in quei cassetti della memoria che sono lì chiusi ma sempre presenti.
Personalmente nonostante all’inizio fossi terrorizzata di intraprendere questo percorso posso ad oggi dire di essere entusiasta di averne fatto parte come professionista e come persona. Spero però brutto mostro che sarai presto emarginato ed eliminato, ma siccome sono una persona scaramantica ti dico arrivederci..sperando vivamente che sia presto un addio.
4 luglio 2020