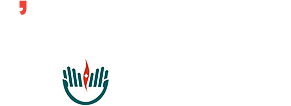Ne posso parlare liberamente adesso, che è finita. Ho avuto il COVID, sono stato curato in un ospedale genovese per 46 giorni, distribuiti tra pronto soccorso, reparto COVID e pneumologia. Infezione battuta già dopo una ventina di giorni, non la polmonite, devastante, che il virus ha indotto in me e tanti altri.
Sono tornato a casa l’altro ieri sera, pulito come se non mi fossi neppure ammalato. Il recupero completo avverrà col tempo, mi aiuterò con le cure e con la pratica della normalità, che tanto può. Il rischio di essere arrivato a fine corsa è stato reale, e mi ero già disposto all’eventualità.
Gli esordi di questa storia sono stati davvero difficili. Il giorno del mio ricovero il 23 marzo, e il successivo 24 hanno segnato le cronache cittadine, e non solo, per l’assalto ai Pronto Soccorso. Il numero di picco raggiunto: 192 ricoverati, per una struttura che ne potrà accogliere un terzo. Primi quattro giorni in barella, non proprio un sogno per le persone delle mie dimensioni. La scena poteva effettivamente ricordare la guerra: mancavano i segni fisici delle ferite e delle distruzioni, ma le facce erano quelle di chi era sfollato da un bombardamento.

La paura dominava assoluta. Io non sono facilmente impressionabile, ma non era possibile estraniarsi da un contesto da incubo solo per pensare a sé. C’era chi si lamentava, chi piangeva, chi gridava e chi cercava semplicemente una mano da stringere. Un uomo giovane, padre di una bambina di due anni, è stato tenuto per mano dall’infermiera per più di due ore, e poi se n’è andato.
Se trovo chi parla male della sanità pubblica, lo metto in condizioni di ricovero immediato in traumatologia. Senza di questa, non oso pensare come sarebbe stato gestito il flagello. Se la professionalità è un obbligo, non altrettanto lo sono umanità e dedizione. Ne ho trovate entrambe in quantità industriale, e un livello di consapevolezza del corpo medico, infermieristico e degli altri operatori che ha spinto chiunque oltre i propri obblighi e i propri limiti, per acquisire conoscenze nuove sul nemico peggiore: un male sconosciuto. Alla cura si associava l’aggiornamento continuo, che rimbalzava da ospedale a ospedale, in Italia e nel mondo. Questo, nella penuria di dotazioni, tipica dell’evento improvviso. L’iniziativa personale ne è stato il tratto distintivo.
Come paziente, posso dire che l’assunzione di responsabilità è fondamentale: se in un simile marasma privatizzi la tua sofferenza riducendola a un rapporto compulsivo con il campanello per chiamare l’infermiera, ritardi la tua guarigione e peggiori la vita a tutti. Il contesto emotivo è decisivo, le morti erano la normalità; nel mio reparto hanno perso un medico e un’infermiera, che fino a pochi giorni prima si erano prodigati per arginare il disastro. E’ importante la consapevolezza di essere solo una parte di una comunità dolente. Questo ti consente di dimensionare correttamente il tuo stato, senza peggiorare la vita tua e di tutti. Non è facile, ma devi riuscirci.
I giorni e, spesso, le notti sono stati segnati da lamenti e preghiere e da tanta paura. Nei giorni del pronto soccorso ho provato a propormi, a chi stava peggio di me. Chissà, magari un po’ è servito. Una speranza, però, è stata data da valori inaspettati. Per esempio,da non credente sono rimasto colpito dal fatto che qualcuno abbia voluto includermi nelle sue preghiere. Ho il massimo rispetto della spiritualità di ognuno, e ho raccolto questa disponibilità come un privilegio.
Detto questo, la percezione positiva che già avevo del corpo infermieristico si è trasformato in pura ammirazione. L’importanza di ciò che fanno, in un contesto contrattuale vergognoso, è enorme. Vorrei ringraziarli tutti, uno per uno, e invece li incontrerò per strada senza poterli riconoscere, per via delle protezioni indossate. Mi farò bastare i loro nomi, i loro sguardi, e le loro voci.
13 maggio 2020