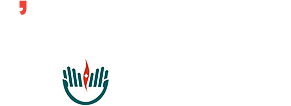Simpatia, compassione, empatia. Qualsiasi ragionamento sulle modalità del sentire l’altro necessita di un preliminare inquadramento terminologico. La letteratura infermieristica, da tempo, pare fortemente orientata all’analisi del concetto di compassione e delle sue implicazioni pratiche (Crawford, Brown et al., 2014; Mc Caffrey e Mc Connell, 2015; Blomberg, Griffiths et al., 2016), cosi come all’esplorazione degli effetti della compassionate care su pazienti e operatori (Sacco e Copel, 2018; Coetzee e Laschinger, 2018).
Il termine compassione è concordemente definito come la consapevolezza della sofferenza altrui unita al desiderio di alleviarla (Sinclair, Norris et al., 2016). In tal senso è il movimento interiore che dal comprendere genera il desiderio di agire, che distingue la compassione dai sentimenti associati come l’empatia e la simpatia.
Il termine empatia fu introdotto in letteratura dallo psicologo strutturalista Edward Titchener nel tentativo di tradurre il termine tedesco Einfühlung (sentire dentro), utilizzato dal filosofo Theodor Lipps per spiegare come le persone diventano consapevoli degli altrui stati mentali. La definizione del termine riguarda la capacità di comprendere e condividere i sentimenti e i punti di vista degli altri, nonché l’uso di questa comprensione e delle correlate emozioni, come guida per il comportamento (Jeffrey, 2016a).
La simpatia invece si riferisce a una reazione emotiva di benevolenza verso la sfortuna di un altro, specialmente nei confronti di coloro che sono percepiti come ingiustamente sofferenti (Jeffrey, 2016a). Nel vissuto di simpatia gli aspetti affettivi possono talvolta sovrapporsi a quelli sperimentati nel vissuto di empatia, ma non esiste la preoccupazione di “sentire dentro” lo stato emotivo e i sentimenti o di comprendere il punto di vista dell’altro. In tal senso è possibile provare simpatia verso persone sconosciute o anche inesistenti, come i personaggi di un film o di un romanzo. Anche nella compassione non esiste la preoccupazione di “sentire dentro” lo stato emotivo, i sentimenti o il punto di vista dell’altro. Si sperimenta compassione, solitamente, quando interagiamo con altri che stanno vivendo situazioni critiche e sfortunate, ma, rispetto alla simpatia, solo laddove le situazioni sono oggettivamente gravi. Come ricorda Jeffrey (2016b) si può provare simpatia per qualcuno che perde un treno, ma certo non compassione.
Per quanto sinora descritto pare possibile distinguere i vissuti di simpatia e compassione da quelli di empatia. Non ci sono dubbi che dal punto di vista applicativo il costrutto di compassione risulta più appropriato, dato che unisce alla semplice consapevolezza interiore la motivazione al “fare”. Bloom (2017) non ha dubbi: il “sentire dentro” empatico è una bella cosa, ma va abbandonato perché è dannoso.
Associato a potenti pregiudizi genera aggressività: focalizzando l’attenzione sul benessere di individui specifici, a cui teniamo, motiva le rappresaglie verso coloro che li hanno fatti soffrire. O anche, favorisce le espressioni di localismo, razzismo e nazionalismo laddove il “sentire dentro” è guidato dall’identificazione in chi più ci è vicino o ci somiglia (pregiudizi ingroup), ovvero quasi sempre. Oppure, in alcuni casi, può favorire i pochi rispetto ai molti: se viene mostrato il nome e l'immagine di un bambino che ha bisogno di una medicina salva-vita, le persone tendono a prodigarsi maggiormente e ad elargire più denaro rispetto ad una semplice comunicazione riguardante dieci generici bambini con lo stesso bisogno (effetto vittima identificabile).
Anche se ben amministrato, il sentire empatico può rilevarsi un motivatore inefficace, in quanto può portare a esaurimento emotivo e burnout. Bloom (2017) consiglia: abbandonate l’empatia e abbracciate la compassione, l’empatia ha un lato oscuro e non serve, può essere sostituita dalla compassione. Le decisioni morali possono essere prese attraverso calcoli utilitaristici dei costi-benefici o facendo appello a principi morali universali. Inoltre, possiamo essere motivati ​​dalla compassione e dalla preoccupazione a prendersi cura del benessere altrui, senza necessariamente “sentire dentro” il loro dolore. Detto questo, possiamo abbandonare il costrutto di empatia nella pratica clinica? Non c’è altro di utile da sapere? Che differenza c’è, se c’è, tra il sentire dentro della compassione rispetto a quello dell’empatia? Quali le implicazioni pratiche?
Oltre gli stereotipi e le definizioni strette
Nell’allontanarsi dall’uso di definizioni eccessivamente ristrette, Zaky (2017) ricorda che le teorie più influenti concordano sul fatto che il costrutto di empatia descrive molteplici processi distinti, ma collegati, attraverso i quali le persone rispondono in modo molto diversificato alle emozioni, ai sentimenti ed ai punti di vista degli altri. Questi processi includono:
- una componente affettiva, il sentire dentro i sentimenti degli altri
- una componente cognitiva, il ragionamento sulle emozioni degli altri sino alla consapevolezza interiore
- una componente motivazionale, il desiderio di fornire aiuto.
L'uso del costrutto di empatia come termine generico descrittivo di più processi permette l’analisi dell'emozione interpersonale, nello stesso modo in cui il costrutto di memoria riunisce i molteplici processi attraverso i quali il passato influenza le persone. L’empatia così definita può essere controllata. Le persone orientano le loro emozioni verso i fini cognitivi e i valori che già possiedono e cambiano i loro stati emotivi per allinearli a questi. Anche secondo Västfjäll (2017) le emozioni non sono buone o cattive di per sé ma dipendono fortemente da fini e valori personali, nonché dai contesti in cui detti fini e valori si esplicano. È proprio la mancanza di questa consapevolezza sulla controllabilità delle emozioni che spinge all’uso di definizioni ristrette e fuorvianti. L’uso del costrutto di empatia come termine generico permette di non rilevare differenze eclatanti tra empatia e compassione, semplici gradienti di un unico continuum di infinite modalità di percezione degli altri. Detto questo, nei modi di sentire l’altro esiste invece una differenza fondamentale.
Prospettive
Secondo Jeffrey (2016a), nel sentire empatico (quale che sia) possiamo adottare due diverse prospettive. Nelle prospettive ego orientate (orientate al proprio sé) si crede di essersi calati nell’altrui situazione illudendoci che gli altri sentano e pensino come noi, una sorta di identificazione cognitiva. Con la lettura cognitiva non possiamo riuscire a comprendere la reale esperienza dell’altro. Si tratta di una credenza pericolosa che crea una serie di problemi: errori predittivi, false ipotesi e sofferenza esistenziale. Altro problema di questa prospettiva è che se il sanitario si concentra troppo sulla sofferenza (propria) tenderà ad allontanarsi dall’altro per tentare di alleviarla. Questi operatori sono ad alto rischio di burnout, non distinguono il proprio sentire da quello degli altri.
Al contrario, la prospettiva etero orientata (orientata all’altro) permette di evitare le false assunzioni, gli errori di predizione e l’angoscia. L'empatia nella prospettiva etero orientata inizia con la curiosità e l’immaginazione. In questo caso si immagina deliberatamente di essere l’altro e di vivere l'esperienza dell’altro come se fossi l’altro piuttosto che razionalmente pensare cosa (io stesso) sentirei se dovessi (io stesso) vivere l'esperienza dell’altro. L’approccio etero orientato è incredibilmente sofisticato e richiede flessibilità mentale, capacità di regolare le proprie emozioni e capacità di sopprimere la propria personale visione delle cose. In questo modo non c’è identificazione e si mantiene la consapevolezza del confine tra sé e l’altro.
Visioni
Ancora Jeffrey (2016b) propone due visioni del sentire empatico che qui si riassumono.
Nella visione ridotta (stretta, ego orientata) l’empatia è considerata una comprensione intellettuale dello stato affettivo dell’altro, una forma di disinteressata preoccupazione, può anche essere chiamata empatia cognitiva ed è da considerare come un espressione delle individuali capacità di mentalizzazione.
Nella visione ampia (etero orientata) l’empatia consiste invece nella condivisione di sentimenti ed emozioni, una vera e propria connessione a livello emotivo. La visione larga dell’empatia richiede l’autoanalisi e la selezione di comportamenti, cognizioni, affettività e atteggiamenti morali che assumeranno differenti configurazioni nelle disparate situazioni cliniche. In questo modo l’empatia può divenire una tipologia di comprensione unica, attraverso la quale sperimentiamo cosa sia essere l’altro.
Al centro del modello di Jeffrey si trova la deliberata connessione a livello emotivo (primo passo) che comporta l’assunzione della prospettiva del paziente, il sentire dentro l'angoscia del paziente. Laddove l’operatore riesce a sentire l’altro, ad assumerne la prospettiva soggettiva, diviene in grado di riflettere (secondo passo) su quelle stesse emozioni sapendo che originano dall’altro. Punto cruciale del modello è la cognizione (terzo passo), il processo mentale di acquisizione di conoscenza e comprensione attraverso (o mediante) i pensieri, la prospettiva e il vissuto dell’altro. Se l’operatore ricerca attivamente la comprensione di cosa significhi essere quel paziente e proprio quello, se cerca di vedere il mondo dalla sua prospettiva, la ricerca stessa lo protegge dalla sofferenza derivante dalle prospettive ego-orientate che impediscono di comprendere dove finisce il sé ed inizia l’altro. Non c’è confusione. Al contrario, se i professionisti sanitari tentano di sopprimere i loro sentimenti distaccandosi emotivamente dai pazienti, con la disinteressata preoccupazione, non possono riuscire ad evitare di avere inconsci atteggiamenti emotivi nei confronti di quegli stessi pazienti.
Tornando al modello, l’approccio empatico in senso largo dipende dalla curiosità o dall’interesse per le preoccupazioni, i sentimenti e l’angoscia del paziente. La curiosità richiede sempre una sospensione del giudizio, aprendo la strada all’incertezza. L’incertezza inibisce l’ingenua simpatia iniziale, basata sulle sensazioni derivanti dal primo impatto o dal mero aspetto esteriore. L’incertezza previene anche l’instaurarsi di meccanismi proiettivi da parte dell’operatore. La relazione empatica così instaurata non può che essere dinamica, basata su azioni concrete che manifestano la preoccupazione e la considerazione per l’altro, trasmettendo sensazioni di importanza che sostengono la dignità personale del paziente e la certezza che non sarà mai abbandonato, ovvero, l’assistenza basata sull’empatia, intesa in senso largo, assume una dimensione etica.
La pratica dell’empatia in senso largo necessita di umiltà: non è mai possibile comprendere completamente i pensieri, le convinzioni, i sentimenti di un'altra persona, si tratta di operare continui aggiustamenti e approssimazioni. Questa relazione richiede una continua operatività, che fornisce informazioni di ritorno sull’accuratezza delle cognizioni.
Infine la reciprocità: l'empatia in senso largo è una relazione a due vie, consente anche al paziente di immaginare il punto di vista e sentire il vissuto dell’operatore.
Le forme di empatia in senso largo sono molteplici. Varieranno al mutare dell’equilibrio degli elementi del costrutto nei vari contesti clinici. Un appunto da tenere a mente: lo sviluppo di capacità empatiche, in senso largo, non è qualcosa che succede, è una scelta e richiede preoccupazione e sforzo.
Conclusioni
Simpatia, compassione, empatia in senso stretto e largo. In fondo niente di nuovo. Certo non pare possibile abbandonare il generico costrutto di empatia come principio guida della pratica. Da una prospettiva assistenziale le azioni e le prassi adottate dai sanitari sono parte integrante della loro vita morale, ovvero il sentire empatico è un elemento discriminante della qualità assistenziale. In altre parole: il sentire empatico è uno strumento essenziale per lo sviluppo della comprensione degli altri, comprensione profonda che ci consente di decidere quale sia la migliore linea d'azione per quello specifico e unico assistito. L’analisi di questi concetti non dovrebbe essere finalizzata all’individuazione del metodo migliore e assoluto da adottare in ogni relazione, ma fornire indicazioni sull’appropriato approccio per ogni singolo caso, per ogni diversa situazione clinica.
Esistono contesti clinici dove sono richiesti bassi livelli di relazione. Invece, se si opera in contesti dove le interazioni e la contiguità con l’utente sono intense e prolungate nel tempo, dove scompare l’utente e appare la persona che affronta cruciali passaggi di vita, la relazione diviene strumento terapeutico e l’incompetenza relazionale diviene colpa e dolo. L’oncologia, l’hospice, tutta l’area della cronicità e della fine della vita, le residenze sanitarie, le cure domiciliari, l’area psichiatrica e dell’igiene mentale richiedono all’operatore sanitario, oltre alla competente efficienza ed agli efficaci trattamenti, eccellenti capacità terapeutico-relazionali, impossibili da attuare senza la conoscenza dei principi base dell’intimo funzionamento del sentire empatico.