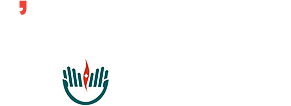Lucetta Fontanella è una paziente particolare: sopravvissuta ad una grave patologia grazie ad un ricovero in una Terapia intensiva aperta ai familiari sulle 24 ore, alla sua dimissione ha deciso di raccontare la sua esperienza attraverso libri, scritti, un sito dedicato e il suo blog, riunioni e conferenze. Sicuramente in questo ha messo a frutto le sue competenze di docente di Didattica dell’italiano alla Facoltà di lettere dell’Università di Torino, ma il suo progetto di porte aperte per le Terapie intensive va oltre il semplice abbinamento di vita privata e strumenti professionali.
Da tutto questo è scaturito un libro, La comunicazione diseguale. Ricordi d’ospedale e riflessioni linguistiche, mediante il quale il caso di Lucetta è diventato d’interesse nazionale. È significativo che l’autrice abbia scelto di devolvere il ricavato della vendita del libro al servizio di Terapia intensiva dell’Ospedale S. Giovanni Bosco di Torino: segno di un’elaborazione personale che vuole però essere di aiuto. Da più punti di vista, alla comunità più ampia di coloro che sono passati da quelle stanze.
Lucetta ha insegnato per molti anni Didattica dell’italiano presso il Dipartimento di Scienze del linguaggio e letterature moderne e comparate alla Facoltà di lettere dell’Università degli Studi di Torino. Oggi si definisce una pensionata felice perché ha molto tempo per occuparsi di ciò che le interessa. Oltre a fare la nonna, continua ad occuparsi di comunicazione, soprattutto in ambito sanitario.
Esiste davvero una comunicazione diseguale?
Non solo esiste, ma è diffusissima. Incredibilmente più diffusa di quella uguale. E sempre, quando la incontriamo, non ci piace. Ci sono però degli ambienti in cui non solo non ci piace, ma davvero ci disturba e compromette rapporti e situazioni. Sono ambienti molto delicati nella nostra società e dunque nella nostra vita. L’ospedale è uno di questi (ma anche la scuola o la famiglia…).
Che cosa accade di diseguale nell’ospedale?
Beh, in ospedale accadono cose ovvie:
- ci sono i sani da una parte e i malati dall’altra;
- c’è un mondo orizzontale che deve avere rapporti con un mondo verticale e la cosa non è davvero facile;
- c’è l’incontro obbligato fra individui che non si conoscono.
Accade che alcuni hanno più potere di altri e questi alcuni stanno tutti dalla stessa parte: sono quelli che nell’ospedale ci lavorano. Avere più potere è come dire che si sentono padroni dell’ospedale. Ma potremmo anche dire, perché è la stessa cosa, che sentendosi padroni dell’ospedale si attribuiscono molto, molto più potere rispetto ai malati e ai loro parenti. Sentirsi padroni di uno spazio significa, per il modo abituale e consolidato di vivere nella nostra società, sentirsi legittimamente autorizzati a fare tutta una serie di cose. Chi entra in casa nostra sa che deve rispettare certe regole che, in grandissima maggioranza, evidenziano appunto, con atteggiamenti convenzionali, il riconoscimento della proprietà. Chi entra deve segnalarsi, chiedere permesso, anzi tutta una serie di permessi, deve, sempre, pazientemente attendere di essere invitato a fare i diversi atti. Entri… si tolga la giacca, se desidera… si sieda… prende qualcosa? Nessuno entrerebbe, si toglierebbe la giacca, si siederebbe, andrebbe a prendersi qualcosa in cucina senza esplicito invito. Siamo educati a rispettare queste regole da subito, da piccoli. La chiamiamo buona educazione. Ma se non siamo in presenza di un legittimo proprietario queste cose non le facciamo, non riteniamo di doverle fare. Fra comproprietari ci si comporta in un altro modo. Anche questo lo impariamo già da piccoli.
Di chi è l’ospedale?
Qualcuno, in uno slancio di apertura verso il mondo dei malati, potrebbe dire che l’ospedale è dei malati, ma ben presto ci si accorge che in realtà, in una società come la nostra (molto avanzata da certi punti di vista), l’ospedale deve essere considerato un bene, dunque uno spazio, comune, di tutti noi cittadini. Ciascuno, dentro l’ospedale, ha ruoli, mansioni, responsabilità diverse: tutti questi soggetti, a buon diritto, ritengono di contribuire col proprio lavoro alla definizione di uno spazio comune, così come alla formazione degli operatori. Dunque ciascuno di noi, in ospedale, si aspetta di sentirsi in un luogo civilmente condiviso. Quando, già dal primo passo oltre la soglia, ci si accorge che questo non accade, scattano atteggiamenti di disturbo, poi di messa in guardia, poi di difesa e molto spesso di reazione. Non sono, nella maggior parte dei casi, dinamiche razionalizzate, sono per lo più reazioni spontanee. Come quelle che si generano quando qualcuno ti passa davanti in una coda di attesa e fa finta di niente o in generale quando sei implicato in un vistosissimo e negato atto di maleducazione, se non di violenza.
Esistono segnali di rottura della convivenza civile che l’ospedale manda a chi ci entra?
Se esistono! Sono tanti, davvero tanti. Anzi, troppi per essere accettati. La perentorietà delle informazioni, spesso con toni minacciosi (ogni testo che inizi con vietato è di fatto una minaccia), la limitazione unilaterale degli spazi, la limitazione unilaterale dei tempi di accesso, l’organizzazione della vita dei pazienti. Proviamo a vederli questi segni di rottura:
- tutti in pigiama anche se non serve;
- gli orari dei pranzi e delle cene così difformi dalla quotidianità;
- le limitazioni pretestuose alla libertà di gestire le poche cose personali;
- la totale svalutazione del concetto di tempo per i pazienti – si aspetta ore senza che mai nessuno si scusi;
- il disinteresse per il malato, in quanto individuo;
- l’appropriarsi di funzioni di cura che sono primariamente dei parenti e amici, che devono però avere tempo e modo di poter provvedere.
Gli esempi possono essere questi e tantissimi altri.
Perché in ospedale si utilizza una lingua non condivisa, anzi, una lingua che divide?
A questo punto occorrerebbe fare una digressione sulla situazione linguistica italiana, molto particolare. Forse però può essere sufficiente ricordare che in Italia si parla una gamma di italiani, cioè di varietà dell’italiano (non si tratta dei dialetti), molto diversi fra di loro, soprattutto molto diversi nelle aree estreme della gamma. Chi è cresciuto in una famiglia che usa un sistema linguistico basso, se poi ha avuto una scarsa scolarizzazione e non ha l’abitudine di leggere, difficilmente capirà chi ha una lingua alta, frutto di un ambiente familiare con un buon sistema linguistico, di una buona scolarizzazione e magari di una buona attitudine alla lettura. Dobbiamo poi anche pensare che l’ospedale usa moltissimi tecnicismi, che nella vita quotidiana di un individuo si sentono poco o pochissimo, dunque risultano difficili (la difficoltà di una parola dipende esclusivamente dall’uso che se ne fa). Anche termini come diagnosi, prognosi, terapia, (l’elenco potrebbe essere lunghissimo) non sono comprese da una percentuale altissima di persone. Oltre ai tecnicismi, c’è poi una sorta di gergo, che risulta altrettanto difficile. La disinvoltura nell’uso di questa lingua incomprensibile ai più è un altro segno di diseguaglianza.
Come riequilibrare la relazione e la comunicazione all’interno di un ospedale?
Anche se non è un toccasana universale, il riconsiderare l’uguaglianza di diritti fra chi lo frequenta (pazienti, parenti, medici, infermieri e altre figure professionali ancora) porta spontaneamente ad evitare le prevaricazioni più vistose o almeno ad isolare i maleducati conclamati. La cosa è in sé molto semplice, ma di fatto non facile da realizzare, perché chiunque lavori in un certo ambiente tende, giorno dopo giorno, ad impossessarsene e a considerare chi lo frequenta episodicamente (pazienti e parenti) come presenze estranee, con tutto ciò che ne segue. Ciò che occorre è un radicato senso civico, più ancora che un paternalistico voler bene ai malati. Dunque non un ospedale più buono verso i malati, ma un ospedale più civile e attento.
La comunicazione diseguale riguarda anche il rapporto tra medico e infermiere?
Si è parlato di diseguaglianza di relazione e comunicazione fra mondo sanitario e malati, ma non è difficile notare come anche all’interno del mondo sanitario esistano squilibri relazionali e comunicativi, che poggiano sugli stessi presupposti di cui abbiamo parlato. Mi ha molto colpita, durante il ricovero più difficile della mia vita, quello che ha dato origine a tante delle riflessioni di cui sto scrivendo, la difficoltà di relazione e comunicazione fra la figura professionale del medico e dell’infermiere. Mi pare che ci sia un buon modo di sintetizzarla: non ho mai sentito chiamare dottore un infermiere laureato, mai durante una lunga degenza in cui ho incontrato moltissimi dottori in infermieristica. È il solo esempio che mi viene in mente di categoria cui si nega il titolo conseguito. Immagino che la motivazione sia “perché non si confondano con i medici”. La cosa non merita commenti.
Nel bene e nel male, sembra proprio che gli infermieri l’abbiano impressionata…
Io non dimenticherò mai gli sguardi di due infermiere ai lati del mio letto in pronto soccorso a commento di una diagnosi e terapia dissennata pronunciata da un medico dissennato. Lo sguardo era eloquente, ma nessuna delle due è intervenuta per esprimere un dubbio. Questo è svilire la propria professionalità e privarne un malato, che ha davvero rischiato la vita.
Ma pure non dimenticherò un’infermiera che ad un chirurgo gioviale ma distratto, che definiva la mia “proprio una bella ferita”, ha saputo e voluto rispondere “non mi pare proprio, anzi direi che c’è una bell’infezione”. È stata una gran lezione di professionalità.
E una seria professionalità sa cercare e creare gli equilibri necessari in uno degli ambienti più delicati della nostra società. Non stupisca il fatto che si attribuiscono più responsabilità a chi nell’ospedale ci lavora: medici e infermieri si formano alla loro professione, i pazienti e i loro parenti, invece, non hanno studiato per diventare dei malati. Molto spesso la malattia coglie di sorpresa, spaventa, distrugge certezze, crea grandi difficoltà. È questa malattia complicata che vi chiediamo di curare.
Potrebbe esprimere un parere sulla opportunità di eventi dedicati a questo tema?
Sono molto riconoscente a chi impiega tempo e fatica per organizzare incontri che chiariscano, anche nei fatti, quanto la comunicazione (parola ormai strausata) sia una realtà dalle mille facce, dai mille modi, dalle infinite implicazioni. Pigiami, vestaglie, letto, flebo, padella, pittura, recitazione, gioco ci possono essere offerti come voci evocatrici più potenti delle parole. Ci ricordano che le situazioni fanno nascere i pensieri e le parole, ma anche i pensieri e le parole fanno nascere le situazioni, ma pure le situazioni fanno nascere altre situazioni. Ciascuno ha guardato, sentito, riflettuto e poi continuerà a farlo perché le immagini e le parole riaffiorano. Io imparo come si lavora, cosa si pensa, come vive dentro l’ospedale chi nell’ospedale lavora. Ho un grande interesse per questo, perché sono molto ammirata da tutti quelli che fanno un lavoro in cui non si può sbagliare. E noi chiediamo anche che lo facciano col massimo, civile, rispetto per noi. Noi non possiamo e non dobbiamo non chiederlo. Dobbiamo però, insieme, trovare i modi perché questo si produca nel modo più spontaneo possibile.
lucetta.fontanella@gmail.com
(Questa intervista è stata rilasciata in occasione del convegno promosso da Nursind, svoltosi a Brescia il 17 novembre 2012)